Non serve discutere se la diffusione delle tecnologie digitali è buona o cattiva. Vale la pena invece non sottovalutare ciò che distingue questo processo: la rapidità, la pervasività e, soprattutto, il rischio di delegare sempre più funzioni alle macchine, dimenticando che le relazioni passano attraverso i nostri corpi. Il problema del mondo algoritmico, spiega con molta lucidità Miguel Benasayag nel suo ultimo libro La tirannia dell’algoritmo (di cui qui è possibile leggere un paragrafo), è che non lascia spazio all’alterità, al conflitto, all’umano. Per questo solo i piccoli gruppi di resistenza, che decidono di agire qui e ora, hanno la possibilità di sottrarsi al dominio dell’algoritmo

La tirannia dell’algoritmo è un libro di Miguel Benasayag da infilare nello zaino insieme a altri strumenti e attrezzi per percorrere il cammino di questa epoca. Non è utile leggerlo per ricavarne rapide argomentazioni circa l’essere pro o contro la digitalizzazione del mondo. Come spiega Benasayag in questo testo e in altri interventi, la digitalizzazione non è né buona né cattiva, è. È in atto e va compresa. Per farlo è necessario prima di tutto collocarla nel tempo e nello spazio.
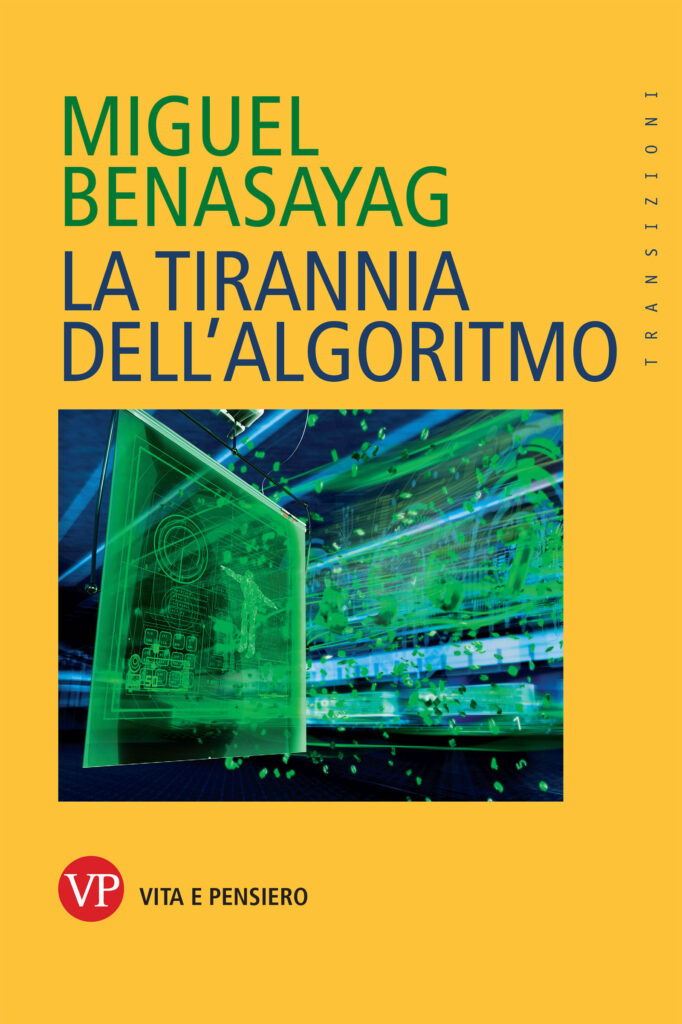
In relazione alla storia della specie umana la digitalizzazione è la terza grande rivoluzione antropologica, dopo l’incontro con il linguaggio articolato e l’invenzione della scrittura. L’elemento chiave di queste svolte storiche è il linguaggio e il suo ruolo in relazione alla conoscenza.
Con la prima rivoluzione antropologica la conoscenza indiretta diventa quantitativamente più importante di quella diretta, ossia l’esperienza perde la sua centralità in virtù della possibilità di trasmissione attraverso il linguaggio. Rappresenta un primo momento di deterritorializzazione, poiché i corpi non hanno bisogno di esperire per conoscere. Con la seconda grande rivoluzione antropologica, che data 3.500 anni, si affaccia la possibilità di materializzare il pensiero attraverso la scrittura.
Dunque nel costituirsi della conoscenza, un’ulteriore lenta e progressiva riduzione dell’esperienza corporea e un aumento delle informazioni, un aumento di quanto perviene dalla conoscenza indiretta. Nel corso di alcune migliaia di anni le culture alfabetizzate contengono il 75-80 per cento di esperienza indiretta, contro il 60 per cento delle culture non alfabetizzate.
La terza rivoluzione antropologica
Con l’avvento della digitalizzazione – la terza rivoluzione antropologica – in trenta-quaranta anni il 95 per cento del sapere e della conoscenza che abbiamo del mondo e di noi stessi diventa indiretto. In questo veloce processo di deterritorializzazione il sapere indiretto non si aggiunge al sapere corporeo, lo sostituisce e lo cancella (Benasayag, Il cervello aumentato, l’uomo diminuito).
Gli studi condotti in ambito neurofisiologico dimostrano che l’utensile, il mezzo, modifica il suo utilizzatore. Il cervello viene modificato plasticamente in quanto le aree adibite a determinate funzioni, se non utilizzate, subiscono la colonizzazione delle aree con le funzioni dominanti.

I dati impressionanti della rivoluzione del digitale, che la distinguono dalle precedenti, sono la rapidità e la pervasività: trenta-quaranta anni e una diffusione mondiale.
Benasayag definisce un cattivo incontro quello tra la specie umana e il digitale. Perché? Il mondo dell’algoritmo arriva in un tempo in cui l’umanità vive una crisi epocale: è la crisi della fiducia nella funzione della razionalità. Con la seconda guerra mondiale si verifica la frattura irreparabile nella razionalità occidentale. Hiroshima, Auschwitz hanno creato un prima e un dopo nell’epoca della modernità. Questo non significa che prima non ci fossero stati eventi orribili, ma qui accade qualcosa di epocale, il crollo di una asse fondamentale. Crolla la convinzione che pensare bene conduca ad agire bene. Hiroshima, Auschwitz rivelano che si può pensare bene il male. Si spezza la convinzione che pensare bene conduca a pensare il bene e anche a agirlo.
Un secondo asse della modernità si frantuma a partire dalla seconda guerra mondiale: crolla la visione della storia con un verso, l’idea del futuro foriero di promesse, la visione vincente del progresso. La digitalizzazione arriva in un’epoca in cui la fede nel progresso sta per essere definitivamente soppiantata da quell’orizzonte di costante minaccia che si è dato come sempre più pervasivo fino ai giorni nostri: la minaccia del cambiamento climatico, la minaccia del terrorismo islamico, la minaccia delle pandemie.
Il rischio della delega
Tenendo conto di questo scenario oscuro e imprevedibile, è forse più comprensibile il fascino esercitato dall’algoritmo. Si presenta come un procedimento che risolve problemi attraverso un numero finito di passaggi, spiegabili, ripetibili, prevedibili. Sempre più funzioni possono essere delegate alle macchine, fino alla funzione stessa della razionalità perduta.
Questa umanità, orfana della fede nella razionalità e sotto costante minaccia di morte, trova nella delega alle macchine sempre più funzioni. L’algoritmo sembra offrire la possibilità di una comprensione completa, consistente e predittiva.
Tutto questo accade ed è promosso dalla convinzione del mondo della scienza che non vi sia differenza qualitativa tra il cervello umano e la macchina. La differenza che la scienza individua è unicamente quantitativa.
In La tirannia dell’algoritmo c’è un passaggio è molto importante per la teoria dell’agire:
“Il linguaggio matematico, come il mondo della lingua in generale e della scrittura, cerca in effetti di far assomigliare il territorio alla carta. lo fa, però, senza negare del tutto la sua alterità rispetto al territorio, che continua a esistere in un rapporto di conflittualità con la carta. E tale dinamica determina le linee di non-compossibilità che retroagiscono per limitare e modificare la carta. Al contrario, nel mondo digitale, il principio del ‘tutto è informazione’ considera i territori come una semplice modalità di esistenza della carta. la violenza della digitalizzazione non risiede quindi in un qualche progetto di dominio, quanto piuttosto in quella negazione di tutte le forme di alterità e identità singolari che porta a una dimensione di pura astrazione”.
Dunque sì, il digitale ci modifica e l’ibridazione dell’umano con il digitale è un dato di fatto. Il problema però non è strettamente la modificazione, poiché in qualche modo sempre il mezzo modifica chi lo utilizza. Il problema è – oltre alla velocità e alla potenza – l’ignoranza degli effetti della modellizzazione digitale rispetto all’alterità. Nel mondo algoritmico non esiste l’alterità. Non c’è l’altro, non c’è l’umano. Ci sono unità di informazioni. Il fenomeno centrale della nostra epoca dunque non è se la macchina possa essere più o meno di aiuto al vivente o più o meno pericolosa. Il fenomeno centrale della nostra epoca ha a che fare con la modellizzazione demografica, economica, dell’educazione, della sanità e le sue conseguenze.
Assistiamo a due processi che si accompagnano e si alimentano. Il primo: il processo di delega agli algoritmi di funzioni, programmazioni, direzioni, decisioni da parte della macroeconomia e dei gestori politici. Il secondo: il rischio nella quotidianità degli esseri umani a livello mondiale, cioè la tendenza all’essere in coppia con il mondo digitale, che non è atto a promuovere la singolarità, l’alterità e la profondità del conflitto ma a risucchiare in un “tutto di informazione astratta”, riducendo progressivamente l’umano a un profilo privo di corpo, dematerializzato. Dislocato quindi nella sua possibilità e capacità di agire.
Solo i piccoli gruppi possono eludere la tirannia dell’algoritmo
Come scrive Régis Meyran nell’introduzione, Benasayag ritiene che solo i piccoli gruppi di resistenza, che decidono di agire qui e ora, potranno eludere la tirannia dell’algoritmo. Oggi agire significa agire contro la cancellazione della alterità, contro la cancellazione del conflitto.

In una visione che non è mai astratta, ma sempre situata, anzi situazionale, si può riconoscere il valore e il senso di questa indicazione per l’agire: un agire molteplice, contraddittorio e conflittuale. Una modalità che assomiglia più alla guerriglia che alla guerra, adatta a muoversi sul campo davanti a un potere colonizzatore pervasivo. Molteplice, contro tutte le logiche di semplificazione. Contraddittorio, per cercare domande e dubbi e incrinare le conferme e il consenso acritico. Conflittuale, ovvero contro soluzioni globali e a sostegno di sperimentazioni e motivazioni immanenti.
Se crediamo che non si distrugga la casa del padrone con gli strumenti del padrone (Audre Lorde), l’invito è di tenerne conto scegliendo strumenti altri da quelli del potere colonizzatore.
Avevamo aperto con l’invito a mettere questo libro nello zaino per percorrere il cammino… ma quale cammino? L’unico possibile nell’orizzonte che abitiamo è quello della poesia di Machado, molto amata da Benasayag.
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar (…)”.
Roberta Padovano e Daniela Portonero, Collectif Malgré tout Italia




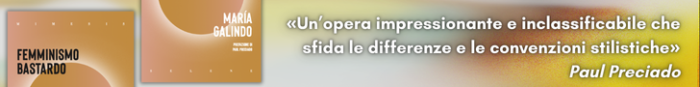
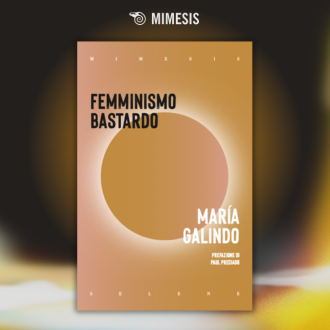






molto interessante e completamente condivisibile. Grazie
“Sotto la logica formale dei computer tutti quanti si trovano in uno stato di coma deambulante.”
La presentazione del libro di Miguel Benasayag “La Tirannia dell’Algoritmo” qui su Comune-info ho già commentato in dettaglio (vedi “Teoria dell’agire”, Miguel Benasayag, 29 Dicembre 2020). Qui vorrei solo richiamare l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti importanti che, a mio avviso, sono stati completamente ignorati dalle autrici dell’articolo di cui sopra.
Inanzitutto, viene stressato soltanto l’aspetto dell’uso delle macchine calcolatrici (“computer”, “software & hardware”, quindi merci, valori, strumenti) come mezzo di controllo sui corpi (“de-territorializzazione”). Viene quasi esorbitato il loro ruolo come strumenti di potere. Sembra che si assumono questo ruolo al di fuori di qualsiasi realtà sociale che viviamo, cioé il sistema del Capitalismo con le sue leggi di mercato, a cui sono soggetti tutti in quanto costretti a vendere la loro forza-lavoro. Manca completamente la dimensione del lavoro salariato e del suo sfruttamento a fine di produrre plusvalore.
La “tirannia degli algoritmi”, quindi, se includiamo queste considerazioni nell’analisi si può precisare meglio seguendo l’analisi proposta dal Collettivo Socialista di Pazienti / Fronte di Pazienti – SPK/PF(H) già nel 2004:
“Sterminio dello sfruttamento (Ausmerze der Ausbeutung) o sfruttamento dello sterminio (Ausbeutung der Ausmerze)?! Entrambi vanno anche insieme, computer-logicamente e in modo semantico-copulativo in ogni caso.”
“Tutto ciò avviene 24 ore su 24 tra i computer, tanto come programma di lavoro quanto come programma per il tempo libero. Tutti sono desiderosi di sfruttare eccessivamente se stessi, come se fossero pagati per questo. […] Dicono che nessuno è mai stato pagato per il suo lavoro, e chi non sfrutta gli altri, sfrutta se stesso, da solo. Si dice che la terra sia uno strumento del capitalismo (mezzo di produzione); la Terra, va aggiunto, una volta è stata colpita da un’eruzione cutanea: l’umanità, che può essere fatta sparire dalla globalizzazione ad opera dei computer (un mezzo di produzione, uno strumento che è impazzito), per il momento l’ultimo SiegHEIL (vittoria per la salute). La dittatura binario-digitale dei computer è sterminio anche attraverso lo sfruttamento eccessivo, sfruttamento di modo formale-logico e logistico-radicale senza niente in mezzo, e lo sfruttamento viene quindi de-attualizzato tematicamente. Il marchio di taratura (Eichmarke) di qualsiasi programma per computer possibile e concepibile non può mai essere chiamato altro che: sterminio. Questa è una nuova variante dell’imperialismo, come lo stadio più alto del capitalismo. L’economia del libero mercato ha già fatto più morti di tutte le guerre messe insieme. Ma quello era ancora sfruttamento, e ancora lungi dall’essere sterminio, semplicemente e totalmente banale eseguito meccanicamente da macchina calcolatrice, solo una variante, una nuova fase transitoria nello sviluppo del tardo capitalistico, tanto antico quanto futuristico imperialismo globale (opera delle ‘camice bianche’, l’imperialismo mentale).”
(si tratta di una traduzione, il testo integrale in lingua spagnolo “Sobre la lucha electrónica de clases”potete leggere sul sito internet dell’ SPK/PF(H)).
La quotazione dal libro di Benasayag circa il “linguaggio matematico”, se lo intendiamo bene, si riferisce alla logica formale su cui si fonda ogni algoritmo, cioé al “tertium non dator” (Aristotele), ovvero la sua versione “moderna” (Betrand Russel) che sta a base delle macchine calcolatrici (computer).
Secondo questa logica, “la “logica della vita” come ha riflettuto FRANCOIS JAKOB per certi circoli rizomaticamente-molecolarmente rivoluzionari, è il prodotto della macchina calcolatrice delle proteini e dei geni. Questa macchina calcolatrice della salute sa leggere l’alfabeto Morse genetico. E sa contare. Naturalmente solo fino a due. E con ciò ci si deve arrangiare. Perché dove essa sbaglia c’è errore. Sia la malattia un errore dentro l’informatica genetica! Nulla più. Secondo questa macchina fa parte del programma della salute geneticamente ancorato che ogni errore deve desiderare la sua eliminazione, e ogni brontolone della salute di conseguenza la sua estinzione.”
(fonte: Numeri e resti” Fronte di Pazienti, publicato in Italia per la prima volta sulla rivista CONTROinformazione no. 18 nel Giugno 1980 sul sito internet del COLLETTIVO SOCIALISTA DI PAZIENTI – FRONTE DI PAZIENTI – SPK/PF(H).
Concludo anch’io con un invito. Per percorrere questa epoca farete bene infilare nel vostro zaino anche il legendario libro dell’SPK/PF(H), tradotto oramai in tutte le lingue maggiori del mondo: SPK – Fare della malattia un’arma, con le prefazioni di Jean-Paul Sartre e di Wolfgang Huber, paziente del Fronte e fondatore del Collettivo Socialista di Pazienti (la riedizione in lingua italiana troverete sul sito internet dell’SPK/PF(H))
L’uso degli strumenti telematici è una conquista dell’uomo sapiens che, incapace, inabile o attempato ha richiesto aiuto anche
da un punto di vista virtuale .
Ma l’uso non comprende l’abuso e, la totale sostituzione del rapporto interpersonale diretto necessario, a completamento della personale consapevolezza d’ogni uomo !
La teoria, nelle migliori realtà scolastiche, s’accompagna sempre ad una eguale se non maggiore dose di pratica …almeno così ho studiato a scuola !!
Interessante e ricco di spunti di riflessione, grazie per la condivisione.