La co-progettazione e l’infrastrutturazione delle reti non sono processi da lasciare al caso o alla sola buona volontà dei soggetti della comunità. Hanno bisogno di persone che conoscano la complessità dentro la quale si dovranno muovere e che abbiano strumenti metodologici consolidati e fondati sull’esperienza. Conoscere l’approccio e gli strumenti tipici della Teoria del Cambiamento può sicuramente fornire un ottimo ecosistema all’interno del quale far nascere e crescere co-progettazioni che aspirino a creare “comunità trasformative”
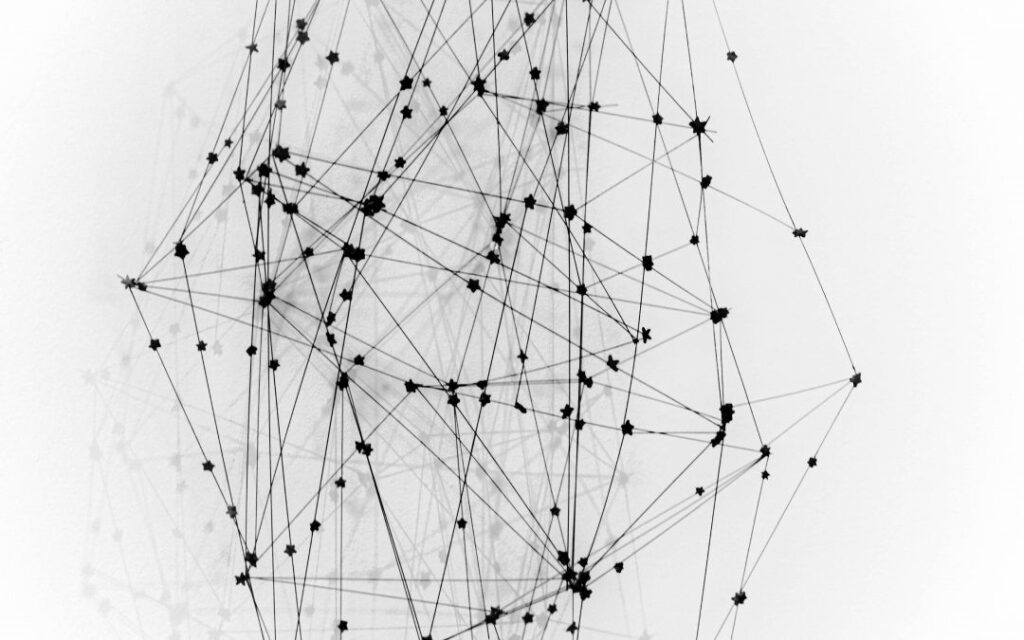
Ci sono alcuni termini che ritornano in continuazione, sono quasi come un mantra. Periodicamente tornano alla ribalta per ragioni legate all’attualità, come il PNRR, le nuove linee guida ministeriali o la Riforma del terzo settore. “Co-progettazione” (prima ancora co-programmazione), “Reti territoriali”, “comunità trasformative” e “Infrastrutturazione sociale” sono fra questi. Sono spesso più evocati che reali, recitati per raggiungere obiettivi utilitaristici (dare conto della propria abilità di finanziatore, accedere ai finanziamenti, ottenere visibilità personale o posizionamento politico ecc.). Quasi mai connotano una situazione reale e solida, in grado di lasciare un segno (un impatto) significativo e di durare nel tempo, consolidandosi e crescendo.
Vi sono certamente ragioni di contesto avverse (economiche, politiche, sociali), che la crisi pandemica ha fatto esplodere ulteriormente. Ma vi sono anche strategie di intervento e approcci che continuano a girare intorno alle questioni centrali senza mai prenderle di petto o, se lo fanno, denotano una eccessiva ingenuità o impreparazione, non imputabile esclusivamente o prioritariamente alle spinte volontaristiche da cui questi processi spesso nascono.
Co-progettazione, comunità e infrastrutturazione sociale sono indissolubilmente legate: non vi può essere infrastrutturazione sociale se non co-progettata (e poi co-gestita) da una comunità e, viceversa, solo una rete territoriale strutturata e integrata in una comunità può nutrire con costanza co-progettazioni di qualità, sostenibili e a impatto.
Le reti e la co-progettazione hanno dimostrato di funzionare se…
Perché ciò avvenga, occorre lavorare su alcuni assi che mi paiono centrali, senza pretese di esaustività:
- La co-progettazione è un processo che va pianificato per tempo e va sostenuto con risorse significative (umane, finanziarie, di competenze, di tempo ecc.), alcune delle quali dedicate quasi esclusivamente a fare funzionare i meccanismi di co-progettazione (facilitatori), da un lato, e a portarla avanti (partner, stakeholders), dall’altra, soprattutto nelle fasi iniziali. Le persone che fanno funzionare la co-progettazione devono essere messe nelle condizioni di farlo al meglio. Soprattutto per le comunità che aspirino a diventare “infrastrutturazione sociale”.
- I processi devono avere regole di ingaggio, di partecipazione e di governance semplici, condivise, trasparenti e democratiche (un vero e proprio “patto di comunità”). Le regole devono essere scritte e controfirmate da tutti gli attori (verba volant… ).
- La Pubblica Amministrazione deve favorire l’ecosistema normativo in cui ci si muove e lavorare per incardinare le pratiche in politiche. Oltre al referente politico, i processi funzionano se sono coinvolti i tecnici, i dirigenti e i funzionari delle amministrazioni locali.
- A proposito di locale, co-progettazione e infrastrutturazione sociale si tengono se l’ambito di intervento è un territorio specifico, limitato (i limiti li auto-definisce la comunità). Il forte radicamento territoriale non è sufficiente a garantire l’efficacia del processo, ma certamente necessario.
- La comunità deve condividere una visione di medio-lungo periodo e valori comuni, fuori da ogni approccio ideologico, centrata su obiettivi di cambiamento che vanno dal sogno (quello che immagina per sé e per i suoi membri) ai passi/progetti concreti necessari per realizzarlo. Tali progetti (per esempio, di rigenerazione di uno spazio, di creazione di un asilo comunitario ecc.) sono strumenti per realizzare la visione, non il fine. Non ci si mette insieme per gestire spazi o servizi, ma per cambiare le cose e vivere tutti meglio, valorizzando le differenze.
- La comunità deve avere cura di portare avanti un sistema strutturato di valutazione dei risultati (Che cosa sta funzionando? Cosa no? Perché?), che attivi un circolo virtuoso di trasparenza (occorre rendere conto di ciò che si fa, dentro e fuori la comunità) e di riflessione continuo.
- Strettamente collegato al punto precedente: devono essere previsti momenti frequenti e strutturati di scambio, autoformazione, capitalizzazione delle conoscenze, delle competenze e dei risultati.
- Occorre promuovere contemporaneamente un cambiamento culturale nei territori, che vada oltre i soggetti che hanno fatto parte del “nucleo fondativo” della comunità, con particolare attenzione ai giovani, altrimenti si costruisce sulla sabbia. La comunità deve rimanere aperta, contaminare e farsi contaminare.
Perché la Theory of Change – Teoria del Cambiamento funziona in questi contesti?
Perché la co-progettazione e l’infrastrutturazione delle reti non sono processi da lasciare al caso o alla sola buona volontà dei soggetti della comunità. Hanno bisogno di persone che conoscano la complessità dentro la quale si dovranno muovere e che abbiano strumenti metodologici consolidati e fondati sull’esperienza. Conoscere l’approccio e gli strumenti tipici della Teoria del Cambiamento può sicuramente fornire un ottimo ecosistema all’interno del quale far nascere e crescere co-progettazioni che aspirino a creare “comunità trasformative”. È stata proprio questa la sfida raccolta dalle Residenze del progetto “Luoghi che parlano”, nel corso delle quali, con un ampia rete di soggetti del Nord (a Milano), Centro (a Rieti) e Sud Italia (a Napoli) si è riflettuto e sperimentato, anche con simulazioni e attività laboratoriali, il processo faticoso ed entusiasmante al tempo stesso di costruzione di una comunità.
Il progetto cui si riferisce questo articolo è “Reti di Comunità Solidali e Competenti: pratiche di Sosten-Abilità e Cura”. È stato proposto da ARCS APS – ARCI CULTURE SOLIDALI Partner: A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus, TAMAT, PATATRAC, Pax Christi, Laudato si’, Fairwatch e Associazione Persone Comuni; ed è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Avviso n. 2/2020.









Ringrazio per questi stimoli, riflessioni ed indicazioni. E’ fondamentale chr gli enti chiamati alla co progettazione la vivano ne come una copia dei propri servizi ne come una integrazione ma come una infrastruttura terza di servizio che nascia ed ha una identita’ propria. Dalle diverse esperienze di coprogettazione sono interessata ad ulteriori confronti di strumenti e buone prassi.