
Ora che la vicenda giudiziaria a danno di Mimmo Lucano si è felicemente conclusa, varrebbe la pena chiedersi perché c’è stato tanto accanimento contro un uomo diventato il simbolo dell’accoglienza felice di coloro che scappano da guerre e fame, da disastri ambientali e governi criminali.
Si capisce adesso perché dava fastidio un modello di accoglienza che valorizzava le aree interne, proprio nel momento in cui si portava avanti ossessivamente una campagna mediatica di invasione dello straniero che, purtroppo, ha messo radici profonde nel nostro Paese. Non a caso la criminalizzazione dell’esperienza di Riace avviene in concomitanza degli accordi delittuosi con la Libia firmati dal governo Gentiloni-Minniti, in base ai quali l’Italia e l’Europa pagano le bande di Tripoli purché trattengano i migranti dell’Africa sub-sahariana.
Non importa come, con quali mezzi e metodi. Quanto sia ancora forte e regga questo mercimonio lo dimostra la vicenda del generale Elmasry, torturatore e stupratore, liberato e rimpatriato con un volo di Stato.
Nel frattempo il cosiddetto «modello Riace» ha fatto scuola, non è più un’eccezione anche se la figura carismatica di Mimmo Lucano lo rende un luogo speciale. Ci sono altri comuni, a cominciare da Camini a soli sette chilometri da Riace, che hanno seguito quella strada con il risultato di aver invertito la curva discendente della popolazione. In tutta Italia le zone interne che hanno accolto gli immigrati hanno potuto contrastare lo spopolamento, mantenendo attività agro-pastorali e artigianali che sarebbero scomparse. Come è successo a Riace, grazie alle famiglie di immigrati si riaprono le scuole, si contrasta la chiusura di farmacie, poste e altri servizi.
LEGGI ANCHE:
Oggi Lucano è al parlamento europeo e sta cercando di portare avanti questa visione. In tutte le aree collinari e montuose europee, esterne ai grandi flussi turistici, il fenomeno dello spopolamento è diventato sempre più grave e preoccupante. Spopolamento significa perdita di cura del territorio, con le conseguenze ben note: frane, incendi, smottamenti e un degrado che dall’alto scende verso valle. Non a caso all’inizio l’esperienza di Riace nel 1999, oltre che dal Cric, venne sostenuta dalla comunità anarchica di Longo basata a Forcalquier (Aix en Provence) e con una presenza di cooperative/comunitarie in diverse aree collinari e montuose della Francia, Svizzera, Germania. Nella comunità di Longo mai era ben presente l’importanza di questa forma di accoglienza per la rinascita delle aree marginali.
In particolare in Italia, uno dei territori più fragili d’Europa, bisognerebbe immaginare un piano di recupero delle aree interne, una seconda «riforma agraria» in chiave ecologica che punti a mitigare gli effetti degli eventi estremi, che riporti la cura del territorio e la sua salvaguardia nelle tante aree collinari e montuose abbandonate. In questa prospettiva il ruolo dei migranti, insieme ai giovani italiani che hanno deciso di restare o di tornare, diventerebbe determinante.
E così oggi, mentre il governo prova ancora, a colpi di decreti legge, a tenere in piedi il fallimentare modello Albania in spregio ai diritti fondamentali delle persone migranti, si può opporre la speranza in un futuro realizzabile, opposto alla barbarie che avanza e all’odio che viene seminato. Come insegna Riace, che all’inizio fu solo un sogno ad occhi aperti.
Pubblicato su il manifesto del 13 febbraio 2025





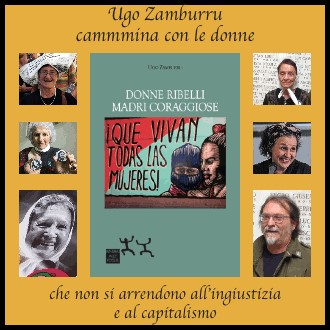






Lascia un commento