La paranoia della “grande sostituzione” ha appena colpito la Tunisia al suo massimo livello: il presidente Kais Sayed ha scatenatao una diatriba pubblica contro l’”invasione subsahariana”, che avrebbe lo scopo di trasformare il Paese in una “terra africana”, cancellando cosi la sua identità “arabo-musulmana”. L’occupante del Palazzo di Cartagine ha fatto proprio il discorso delirante di un gruppetto, il Partito Nazionalista Tunisino, che è sceso in guerra contro l'”invasione”. La Tunisia del 2023 sta scoprendo così quello che l’Italia avevo scoperto negli anni Ottanta: non è più una terra di emigrazione o di passaggio, è diventata una terra di immigrazione. Una situazione in cui il grottesco dei preponderanti compete con la tragedia dei pezzenti. Nejma Brahim, giovane giornalista di Mediapart, è andata a cercare di capire meglio a Tunisi, Sfax e Kerkennah. Fausto Giudice ha tradotto la sua intervista a un esperto in mobilità africana in Tunisia – il geografo Camille Cassarini – per Tlaxcala e ce l’ha inviata per la pubblicazione su Comune

In un contesto in cui il Partito nazionalista tunisino attacca violentemente la comunità subsahariana e in cui i naufragi in mare sono in costante aumento, il geografo Camille Cassarini ripercorre l’evoluzione della presenza africana nel Paese maghrebino, le cui politiche migratorie non sfuggono ai meccanismi che si possono osservare in Europa.
Diciottomila persone sono riuscite a raggiungere l’Italia dalle coste tunisine nel 2022. Questo dato è in costante aumento negli ultimi anni, a dimostrazione che la crisi socio-economica e democratica in cui sta sprofondando la Tunisia spinge costantemente le persone a cercare l’esilio.
In un momento in cui i naufragi sono in aumento e il ritrovamento del corpo di una giovane ragazza “spiaggiata” sulle isole Kerkennah il 24 dicembre scorso ricorda brutalmente la violenza delle politiche di chiusura delle frontiere, Camille Cassarini, ricercatore all’Università di Genova e ricercatore associato al LPED/IRD ( Laboratorio Popolazione – Ambiente – Sviluppo/Instituto di Ricerca per lo Sviluppo), allerta sulla necessità di riconoscere l’immigrazione africana in Tunisia.
Dopo aver trascorso diversi anni a Sfax, una città con una comunità subsahariana particolarmente numerosa, per completare la sua tesi di dottorato (Migrazioni africane, ambito e territori dell’assistenza in Tunisia) il geografo nota che un certo numero di persone viene in primo luogo per studiare e lavorare.
“Le persone subsahariane vengono strutturalmente irregolarizzate dallo Stato tunisino e la loro partenza si basa principalmente su questo contesto di vulnerabilità giuridica”, sottolinea questo specialista della mobilità africana in Tunisia, secondo il quale il rilascio di un permesso di soggiorno e l’apertura dei loro diritti potrebbe consentire ad alcuni di proiettarsi in Tunisia. Dobbiamo smettere, dice, di pensare a queste mobilità in termini di transito verso l’Europa.

Da quando esiste una presenza di esuli subsahariani in Tunisia?
Dagli anni ‘80, con gli studenti provenienti soprattutto dalle classi medie superiori che venivano a formarsi negli istituti pubblici tunisini. C’è stato un primo cambiamento negli anni ‘90, che ha corrisposto alla grande scommessa di Ben Ali sull’istruzione privata, volta ad attrarre le cosiddette “classi medie emergenti” dall’Africa.
È così che abbiamo visto arrivare camerunesi, congolesi, senegalesi o ivoriani. Allo stesso tempo, esisteva già una mobilità di lavoratori che arrivavano in Tunisia e poi cadevano in una situazione irregolare, ma di questo non si parlava affatto.
Un secondo cambiamento è avvenuto nel 2003, con l’arrivo della Banca africana di sviluppo e del suo personale che, in seguito agli eventi in Costa d’Avorio, è stata trasferita a Tunisi. Infine, nel 2011, l’arrivo al potere di Alassane Ouattara in Costa d’Avorio ha messo molti ivoriani sulle vie della migrazione. Si stimava che ci fossero alcune migliaia di ivoriani a Tunisi e alcune centinaia a Sfax. Questi numeri sono cresciuti molto negli anni successivi. Direi che oggi in Tunisia vivono tra le 30.000 e le 50.000 persone provenienti dall’Africa subsahariana.
Qual è il loro profilo?
Sono in gran maggioranza degli ivoriani, il che è di per sé una particolarità, o addirittura un paradosso, perché la Costa d’Avorio non era un Paese di emigrazione, a differenza di altri Paesi dell’Africa occidentale. È particolarmente evidente la presenza di lavoratori dei due principali gruppi socio-etnici della Costa d’Avorio (gli Akan e i Baoulé, oltre ai Bété, vicini a Laurent Gbagbo), che in precedenza non migravano affatto al di fuori della Costa d’Avorio e che provengono da strati sociali abbastanza benestanti.
In quali condizioni vivono?
Fino Alla pandemia di Covid-19, tutti questi gruppi vivevano di lavori relativamente precari; non solo lavori a giornata, pagati 25 dinari [= 8€] al giorno, ma anche attività commerciali “alla valigia” (cioè portare prodotti dal paese d’origine per rivenderli in Tunisia);
Questa popolazione è arrivata in aereo senza visto e ha vissuto in una situazione irregolare (poiché una volta scaduti i tre mesi di permanenza autorizzata, non aveva più il diritto di rimanere), in alloggi collettivi o talvolta individuali e in condizioni relativamente precarie; ma condizioni che, considerata la loro precedente situazione in Costa d’Avorio, non erano necessariamente così negative.
Il loro stipendio permetteva loro di inviare denaro e di mantenere le loro famiglie. Questo era particolarmente vero dato il tasso di cambio tra il dinaro tunisino e l’euro, e quindi il franco CFA. Dal 2018 in poi, lo Stato tunisino ha sviluppato una politica monetaria diversa, incentivando le esportazioni e abbassando il valore del dinaro. I cordoni della borsa sono stati poi sempre più stretti.

Quale impatto avrà avuto il Covid-19 sulla migrazione subsahariana da e verso la Tunisia?
Poiché queste persone erano per lo più impiegate su base giornaliera, in un mercato del lavoro informale, sono state le prime a perdere il lavoro. Hanno sperimentato un grado di precarietà molto elevato, soprattutto perché non avevano sicurezza sociale, né paracadute, né una struttura familiare che li sostenesse. In questo periodo abbiamo visto comparire per la prima volta fenomeni come l’accattonaggio e i senzatetto. Per quanto riguarda gli arrivi, c’è stato un forte calo, che però è ripreso non appena è stato riaperto il traffico aereo.
Secondo le ONG, la presenza di subsahariani è aumentata significativamente nel 2022. Come lo spiega?
Gli arrivi sono aumentati, sì, ma è difficile dire in che misura. Quello che è certo è che non ci sono più solo ivoriani. Ci sono altre nazionalità che hanno intrapreso questa rotta migratoria e i luoghi di insediamento aperti da questa mobilità. Persone provenienti dal Camerun e dalla Guinea-Conakry, che da tempo utilizzano le rotte migratorie tra l’Africa occidentale e il Nord Africa.
Mentre si trovavano spesso in Libia, Algeria o Marocco, la mobilità ivoriana ha aperto questa rotta attraverso la Tunisia, in particolare fino a Sfax. Questo probabilmente è dovuto anche al fatto che le rotte si aprono e si chiudono continuamente e le persone sono alla ricerca di nuovi percorsi. Ogni gruppo di migranti ha una propria storia migratoria.
Queste diverse popolazioni stanno tutte cercando di tentare la traversata verso l’Europa?
Il mio lavoro mostra che gli ivoriani sono venuti in Tunisia per lavorare e stabilirsi. Queste mobilità sono quindi sempre più simili a un’immigrazione, con persone che rimangono per diversi anni, fondano una famiglia e occupano un posto di lavoro e una posizione sociale in Tunisia. Siamo di fronte all’inizio di un’immigrazione destinata a rimanere.
Per quanto riguarda guineani e camerunensi (e lo dico con molta cautela perché non ho condotto un’indagine in merito), sappiamo che si tratta di gruppi noti per cercare di attraversare verso l’Europa. Sappiamo anche che si tratta di gruppi sovrarappresentati nelle richieste di asilo in Europa. Sono dati su cui possiamo basarci per ipotizzare che non siano necessariamente in Tunisia per restarci, a differenza degli ivoriani. Ma su questo bisognerebbe indagare.
L’arrivo di nuove nazionalità ha cambiato la situazione delle reti di transito?
Sì, queste nuove nazionalità portano con sé l’esperienza della strada e della traversata. Alcune persone hanno soggiornato a lungo in Libia e hanno acquisito buone conoscenze nella costruzione di barche. Quando sono arrivati a Sfax, che è una città costiera con un’intera economia basata sul mare, hanno iniziato a costruire barche o a comprare motori. È il caso dei guineani e dei gambiani. Oggi vediamo nuovi tipi di barche in metallo.
Detto questo, nessuna economia di passaggio ha luogo senza l’avallo, il sostegno e la protezione delle reti tunisine di passaggio verso l’Europa. Chi si trova in una situazione di dominio quotidiano, senza capitale sociale o economico, non ha i mezzi per creare tali reti. I tunisini cercano un pubblico, alcuni subsahariani danno loro accesso a quel pubblico, e poi si tratta di negoziare e fare affari. Se esiste un’economia di passaggio per i subsahariani in Europa, è soprattutto perché esiste un’economia di passaggio per i tunisini in Europa.
Con l’arrivo di queste nuove nazionalità, l’economia del transito si è diversificata. C’è una maggiore offerta di passaggi, per una domanda che non è necessariamente maggiore di prima. La conseguenza è che i prezzi sono diminuiti. Dove prima si dovevano pagare 5.000 dinari [=1.500€], ora ne bastano 1.000 o 1.500 [=300 o 450€] per

Ritiene che il numero di naufragi sia aumentato?
Le organizzazioni della società civile dicono che il fenomeno è in aumento. Ma da quando ho iniziato a lavorare in Tunisia, nel 2017, ho sempre sentito parlare di naufragi e delle morti che ne derivano. Il problema è che è molto difficile contare questi naufragi, non sappiamo esattamente chi muore, perché molte persone scompaiono in mare.
In Tunisia, riteniamo che la questione delle sparizioni stia diventando sempre più importante, in primo luogo tra le famiglie dei tunisini scomparsi che si stanno mobilitando, ma anche tra le famiglie e i parenti dei subsahariani, perché si sono stabiliti in Tunisia. Per gli altri, invece, è più complicato quando sono in transito e non hanno necessariamente parenti in Tunisia. È compito di organizzazioni come la Croce Rossa Internazionale aiutarli a ritrovare un parente scomparso.
Coloro che sopravvivono a questi naufragi riportano forti traumi e in seguito non vengono affatto curati. Questo fa parte dell’intera architettura frontaliera, che consiste nel marcare le persone nella loro memoria, nel loro corpo, nella loro storia.
Cosa spinge le persone a tentare la traversata rischiando di perdere la vita in mare?
Credo che si debba decostruire la logica che porta le persone a partire, soprattutto perché ho conosciuto persone che si erano costruite una vita in Tunisia (come i camerunensi) e che sono partite per l’Europa nonostante tutto. Gli attraversamenti sono anche il prodotto della chiusura delle frontiere in Africa e, senza negare l’influenza degli Stati europei in quest’area, non dobbiamo sottovalutare la capacità degli Stati del Maghreb e dell’Africa di sviluppare le proprie agende strategiche in materia di migrazione.
In Tunisia, i subsahariani vengono strutturalmente irregolarizzati dallo Stato tunisino e la loro partenza si basa principalmente su questo contesto di vulnerabilità giuridica: è perché la circolazione tra i Paesi africani è impedita che queste persone sono portate a partire. O spendono i soldi risparmiati in multe [per il superamento della durata del soggiorno autorizzata, da 20 a 40 dinari per settimana, NdT] per tornare nel loro Paese, o pagano una traversata verso l’Europa, il tutto sotto l’effetto combinato della caduta del dinaro, del rafforzamento dell’apparato di polizia tunisino e di un clima di paura.
È quindi necessario sollevare la questione fondamentale del diritto di residenza dei subsahariani in Tunisia. Non si tratta di nazionalità, ma di ottenere un permesso di soggiorno che dia loro dei diritti. Dobbiamo andare oltre la questione degli attraversamenti per considerare l’immigrazione africana in Tunisia.
La Tunisia nega l’esistenza di questa immigrazione?
Finora non c’è mai stato un dibattito politico o un vero posizionamento degli attori politici nei confronti dell’immigrazione africana in Tunisia. Da tempo il Partito nazionalista tunisino lancia campagne xenofobe e razziste contro la presenza africana in Tunisia, utilizzando la stessa retorica dei partiti xenofobi in Europa, basata sulla teoria della “grande sostituzione”. Per la prima volta, un partito basa la sua retorica sulla presenza africana in Tunisia. Non è un fatto trascurabile, perché il Paese aveva sempre negato questa presenza.
Paradossalmente, questo dimostra che l’immigrazione africana sta diventando un soggetto politico. Non viene più considerata come una sorta di esteriorità, ma viene pensate in termini di società tunisina, naturalmente in modo molto violento, ma questo dà origine a nuovi dibattiti. Inoltre, vediamo attori della società civile che, in reazione a questa campagna, chiedono la regolarizzazione. Infine, c’è una latente e progressiva politicizzazione della questione della mobilità africana. Siamo effettivamente di fronte a un’immigrazione.






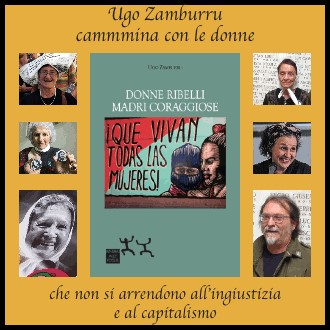





Lascia un commento