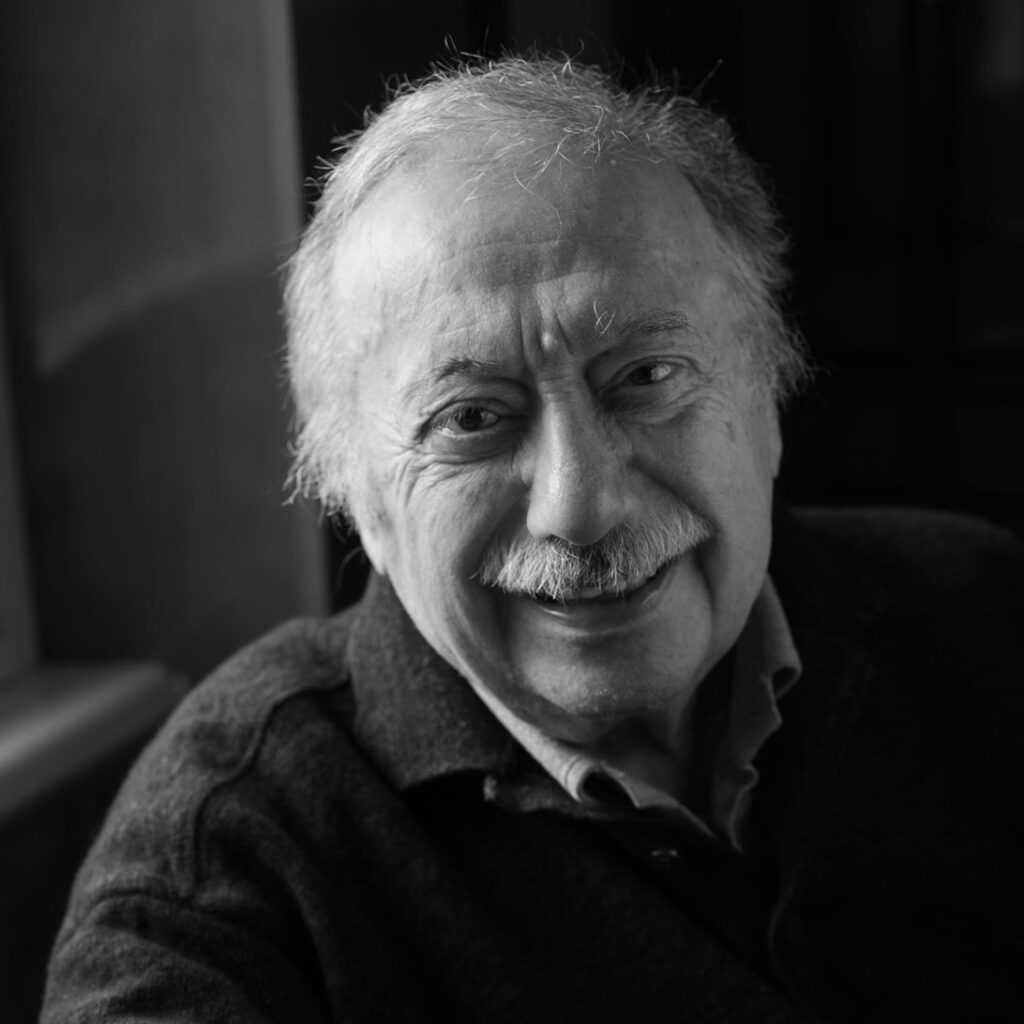
Era la primavera del 2008 o giù di lì, e in una riunione organizzata da Giulietto Chiesa, un mio intervento su Hugo Chávez fece arrossire di arrabbiata passione Gianni Minà. La sua morte, il 27 marzo scorso, mi ha rievocato l’episodio, e oggi – da maestro elementare che faceva il giornalista – penso che la figura di Minà sia un esempio per il giornalismo, per l’insegnamento e per tutti quanti noi.
In pedagogia, il concetto di autenticità è essenziale: con la medesima parola si può definire il lavoro di Gianni Minà, e la sua persona.
Tre lustri fa, a Roma vivevo la fortuna dell’era studentesca e costruivo un capitolo fondamentale del mio romanzo di formazione, tra sogni, presa di coscienza e manifestazioni universitarie blindate dalla polizia (scrissi che La Sapienza fu umiliata).
Frequentavo Megachip – Democrazia nella comunicazione, associazione allora presieduta da Giulietto Chiesa, che un giorno organizzò un incontro per discutere sulla situazione dell’informazione e della politica italiana; acchiappando chissà quale filo del dibattito, intervenni riportando l’opinione del mio collettivo della facoltà di Comunicazione riguardo al presidente del Venezuela. Dissi che per noi Chávez non era un modello, perché a capo di un regime militare: noi ambivamo a una politica non autoritaria. Gianni Minà saltò dalla sedia, e tra l’imbarazzo e lo stupore per avergli fatto gorgogliare il sangue, ascoltai la sua pesante ramanzina: non capivamo niente, in sostanza, perché non eravamo informati sul contesto in cui Chávez operava.
Uscito dalla riunione, nel centro di Roma mi confrontai con un’amica di un movimento non violento, e ci dicemmo che il disaccordo esemplificava la distanza generazionale tra noi e Minà. Insomma, la ramanzina non mi aveva convinto. Anche oggi – pur nella tensione dubitante tra concretezza e ideale – non accetto che un’alternativa politica possa essere affidata alle mani di un esercito, ma ripenso al succo delle parole di Minà, e quanta verità vi risiede per un giornalista, per un insegnante, per un cittadino.
Vale a dire: alla fine tira pure i conti della tua opinione, ma bada bene a inserire i fatti all’interno del contesto, a ragionare calando lo specifico sotto l’ombrello del generale. È la modalità che un insegnante dovrebbe adottare nella valutazione degli allievi, in particolar modo nel primo ciclo di istruzione: considerare non il risultato ma il processo, cioè il cambiamento vissuto dallo studente durante il percorso di apprendimento. In siffatta valutazione echeggiano le parole di don Milani in Lettera a una professoressa: «Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali». Che cosa mormora la coscienza di un maestro elementare, quando – esempio estremo ma realissimo – si tratta di valutare la competenza linguistica di un bambino di origine straniera, e quella di un suo compagno i cui genitori gli leggevano storie in italiano ogni sera, quand’era ancora analfabeta? Per una soluzione al quesito non basta – pur aiutando – la riforma sulla valutazione nella primaria del 2020, perché la scuola andrebbe cambiata nel profondo: tuttavia, anzitutto è responsabilità dell’insegnante lasciarsi interrogare dalla propria coscienza, perché un bambino non è un fiore che cresce solitario, nel contesto di un prato deserto.
Oltre all’importanza del succo delle parole di Minà a quella riunione, ciò che nel ricordo mi sovviene più affascinante è il modo in cui il giornalista rispose al mio intervento. Si irritò, si infervorò, arrossì della genuina incavolatura della passione. Fu la reazione di un uomo autentico, quello stile che poi adorai cercando online le sue interviste alla trasmissione Blitz. Un altro tipo di giornalista avrebbe tentato di trattenersi alle battute di Massimo Troisi. Minà, no: moriva dal ridere, svelando la sua persona oltre al ruolo che ricopriva. Fu anche questa sua autenticità – a dimostrare il connubio tra professionalità e personalità – che gli permise di ottenere la confidenza di protagonisti della cultura, dallo sport alla politica.
Lo stile personale, nel gergo pedagogico, si chiama postura dell’insegnante. Tutti noi, a pensarci, serbiamo un ricordo sul tipo di persona che era ogni nostro docente, e la differenza nel giudizio sull’insegnante si fonda sulla sua autenticità, sul trasparire come persona che oltre la cattedra trasmette passione per lo studio; su tale base si costruisce la nostra relazione con la materia insegnata. Massimo Recalcati l’ha definita, con un suo libro, erotica dell’insegnamento. Un insegnante autentico si preoccupa di rendere la sua disciplina un’esperienza, dotandola di senso per gli allievi: il distacco dalla realtà è un vulnus dell’istituzione scolastica. A rilevarlo furono i grandi della pedagogia, tra cui Tolstoj, il quale, scrivendo nel 1862 che «dovunque il popolo forma la parte principale della propria istruzione non nella scuola, ma nella vita», indicava – quale arma di dominio dei potenti – l’arretratezza della scuola rispetto allo sviluppo della società nel quotidiano (Lev Tolstoj, Quale scuola? La nascita della pedagogia antiautoritaria nell’esperimento di Jasnaja Poljana, p. 65, Mondadori 1978).
In ultimo, così come i docenti devono ricercare la verità interiore e quella scientifica con i propri allievi, e lottare perché la scuola cambi, pensando a Minà mi sovviene la parola coraggio.
Ricordo un numero di Latinoamerica, rivista da lui diretta, che lessi in quella mia epoca universitaria. Rimasi scioccato da un articolo che riportava come i traumi dei soldati statunitensi reduci dall’Iraq venissero rimossi con un farmaco che annientava la memoria: non una cura, ma un’accetta su giorni di vita. Di un fatto tanto grave – mi dicevo – dovrebbero parlarne tutti i media. Quell’articolo è parte della mia formazione, e insieme a un altro di cronaca quotidiana, costituì la base per alcune righe che scrissi all’inizio di quel 2008. Non avevo mai pensato che avrei potuto inviarle a Minà, e ringraziarlo per la sua arrabbiatura.
MAYDAY
Leggevo sul bus il giornale:
militari americani tornano
dalla guerra
e ammazzano ancora
non per la patria
o la…democrazia
ma per pazzia indottrinata da anni
di muta obbedienza al capo
e perpetuata violenza sul nemico
A casa ammazzano ancora
pure soprattutto i parenti;
un reduce ventenne senza piede
ha scaraventato la figlia
di due anni
contro il muro:
s’era urinata addosso
come una qualsiasi infante
Un altro ha sventato un furto
revolverando
quel povero ladro d’auto
per fare ancora l’eroe
ma poi s’è sparato alla tempia
questo Cristo del Duemila
E il Pentagono accusa
il New York Times d’arbitrarietà.
La società del paradosso e bi-pensiero
caro George
Sbuffava il bus verso l’università
e gli occhi umidi forse trapelavano
l’angoscia dentro me
per queste vittime carnefici
per questa umanità lacerata
dall’odio del potere
A volte vorrei piangere
come un qualsiasi infante
All’ombra d’una libertà statuaria
così fragile nella sua disuguaglianza
il “civile mondo occidentale”
s’imbarbarizza nelle malattie
da sé create e trasmesse.
[D. Ferro]









Gianni Minà , un genuino del nostro tempo ,uno buono direbbero, ma non va bene, no. La realtà è travisata , il potere delle armi e della politica governa questa terra, saccheggiata da ogni parte, e gli infanti subiscono la violenza , fisica e mentale. Poveri noi, pedine e nient’altro.