Negli ultimi vent’anni l’importanza della «questione acqua» ha raggiunto una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, malgrado i processi di mercificazione siano in tutto il mondo sempre più aggressivi. La gestione comunitaria dell’acqua, che pure ha cominciato a prendere forma in tanti territori, resta l’unico vero antidoto alle logiche del mercato perché guarda all’interesse comune e non al profitto per pochi. La prefazione alla nuova edizione di Acqua e comunità, un testo fondamentale scritto da Colin Ward

La crisi idrica è ormai un’evidenza conclamata, con effetti nefasti sulla disponibilità per uso umano, sull’agricoltura e più in generale sull’ambiente. La comunità scientifica è concorde in tal senso e anche i rapporti di diverse agenzie dell’Onu riportano dati inequivocabili a riguardo. Nello specifico, i dati relativi al goal 6 «Acqua pulita e servizi igienico sanitari» dell’Agenda 20301 rendono conto della crisi idrica in atto: nel 2022 2,2 miliardi di persone non avevano accesso all’acqua potabile e 3,5 miliardi ai servizi igienico-sanitari2.
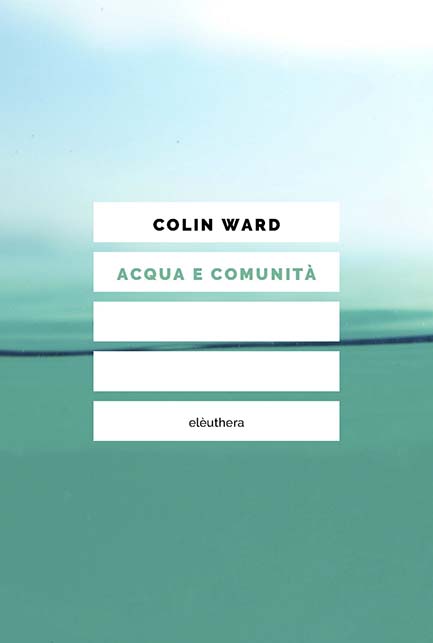
Colin Ward in Acqua e comunità avvertiva di come fosse ineludibile una crisi idrica e intravedeva diversi segnali soprattutto negli effetti derivanti dal «matrimonio» tra il ciclo dell’acqua e il ciclo economico. Ward sottolineava come la crisi idrica fosse dovuta principalmente alla scarsità dell’acqua potabile e di quella utilizzabile dal punto di vista umano e socio-ambientale. Scarsità man-made, cioè prodotta dall’uomo, a partire dall’alterazione del ciclo idrico, dal crescente inquinamento e dall’esclusione delle comunità locali dalla gestione della risorsa. Ward indicava nella gestione comunitaria l’unico vero antidoto rispetto a una gestione insostenibile poiché guarda all’interesse comune e non al profitto per pochi.
Un’analisi simile la elabora Vandana Shiva a inizio anni Duemila quando scrive:
«La crisi dell’acqua è una crisi ecologica che ha cause commerciali ma non soluzioni di mercato»3.
Ciò che all’epoca non era ancora evidente è la sovrapposizione tra un sistema di gestione dell’acqua votato al profitto e a logiche di mercato e gli effetti del cambiamento climatico sulla disponibilità delle risorse. Oggi è indiscutibile come le crisi ambientali e climatiche stiano minacciando le fondamenta degli ecosistemi planetari. Il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, con le temperature globali che si sono avvicinate alla soglia critica di 1,5°C e il 2024, seppur non ancora concluso, sembra abbia abbondantemente superato questo record. Le emissioni di gas serra e le concentrazioni di co2 nell’atmosfera continuano a raggiungere nuovi massimi4. Siamo già arrivati a un punto di non ritorno: in queste condizioni vengono violati i limiti dell’uso sostenibile dell’acqua e sono l’integrità degli ecosistemi e la vita umana stessa a essere gravemente compromessi.
Lo sguardo di Colin Ward, già a fine anni Novanta, aveva individuato esattamente queste criticità, indicando alcune possibili soluzioni e alternative, aprendo una riflessione su quali fossero le dinamiche che intrecciano la crisi idrica alla gestione dell’acqua, i temi ecologici a quelli sociali ed economici, con particolare riferimento al diritto all’accesso all’acqua, ai rischi e alle vulnerabilità derivanti dall’impatto dell’azione umana, dei nostri stili di vita, dei modelli di produzione sulla risorsa stessa e sull’ambiente.
Per queste ragioni diviene utile tornare a riflettere sugli spunti e sugli stimoli che ci aveva consegnato Colin Ward.
Lo stesso Ward aveva evidenziato come la questione rischiava di travalicare i confini del già seppur pericoloso processo di mercificazione dell’acqua e aveva indicato i primi segnali di finanziarizzazione di questo bene con il mercato come unico regolatore sociale.
A livello globale oggi abbiamo la certezza di come decenni di politiche trasversalmente condivise abbiano fatto dell’acqua una merce provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, esclusione delle fasce deboli della popolazione dall’accesso a questo bene, aumento delle tariffe, espropriazione dei saperi collettivi, mancanza di trasparenza e di democrazia, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, riduzione degli investimenti, diseconomicità della gestione, diminuzione dell’occupazione.
Un passaggio epocale è stato fatto nel dicembre 2020 quando, per la prima volta nella storia, l’acqua, come una qualsiasi altra merce, è stata scambiata nel mercato dei «futures» della Borsa di Chicago. L’inizio della quotazione dell’acqua segna un prima e un dopo per questo bene indispensabile per la vita sulla Terra. Si tratta di un passaggio che apre alla speculazione dei grandi capitali e all’emarginazione di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese ed è una grave minaccia ai diritti umani fondamentali. Si apre una breccia che renderà possibile scommettere, attraverso lo strumento dei «futures», sul prezzo dell’acqua regolato in futuro dalla legge della domanda e dell’offerta. Da qui la deriva inquietante per cui il valore dell’acqua aumenterà in maniera proporzionale alla sua scarsità. Questa operazione speculativa rischia di rendere vana nei fatti la fondamentale risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Onu del 2010 sul diritto universale all’acqua, che rappresenta un passaggio storico frutto di grandi mobilitazioni a livello globale per il riconoscimento del diritto all’accesso a questo bene.
Inoltre, è sempre più evidente quanto già sottolineato in maniera preoccupante da Ward: l’acqua è e sarà sempre più obiettivo della politica nazionale e internazionale. Guerre e conflitti per l’acqua si sono succeduti a un ritmo sempre più incessante nel secolo scorso e si avviano a contraddistinguere ancor più questo secolo. In questi conflitti l’acqua viene utilizzata come strumento bellico, di pressione-oppressione e di potere. Le guerre stanno sconvolgendo milioni di vite. Il numero di sfollati forzati ha raggiunto un livello senza precedenti. Quasi 120 milioni a metà 2024 e le vittime civili sono aumentate del 72 per cento tra il 2022 e il 20235.
Certamente Ward ha sempre esaltato esperienze e iniziative dal basso come le uniche in grado di portare a una trasformazione sociale e a garantire l’accesso all’acqua per tutti a un costo equo. Infatti scrive «il problema idrico non è un problema di natura tecnica, ma una crisi di responsabilità sociale». Su questo piano, oggi, siamo nelle condizioni di poter affermare che, in Italia e nel mondo, negli ultimi vent’anni l’importanza della «questione acqua» ha raggiunto una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo intravedere nella battaglia per l’acqua la speranza di un altro modello di società. Si tratta di un percorso che, ispirandosi al concetto di acqua come bene comune necessario alla vita, ha bocciato le politiche fondate sulla trasformazione dell’acqua in merce, chiedendone con forza la proprietà e la gestione pubblica e partecipativa come garanzia di libero accesso per tutti. In Italia, ad esempio, un fragoroso stop alla definitiva privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici locali è stato posto dal referendum del 12 e 13 giugno 2011, promosso da un’ampia coalizione sociale, a partire dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. La maggioranza assoluta del popolo italiano, andando a votare «sì», ha messo un argine all’invasione del pubblico da parte del privato, riportando al centro l’individuo, caratterizzato dai suoi legami sociali, dalla collettività con cui si relaziona («si scrive acqua, si legge democrazia» era il felicissimo slogan di quell’esperienza)6.
A livello internazionale va evidenziato come si stia dispiegando una silenziosa rivoluzione civile con le comunità nel mondo intero che rivendicano il controllo comunitario dei servizi idrici per gestire questa risorsa cruciale in modo democratico, equo ed ecologico. Ciò viene descritto con estrema chiarezza nel 2014 dalla relazione La rimunicipalizzazione dell’acqua come una tendenza globale7: nonostante più di tre decenni di promozione incessante di privatizzazione da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e dei governi nazionali, questo esperimento non è riuscito a rispettare le sue promesse e ha portato molte città a cercare di riprendere il controllo pubblico sulla gestione dell’acqua e sui servizi igienico-sanitari.
Negli ultimi quindici anni i casi di rimunicipalizzazione sono stati 325 in 37 paesi. Più di 100 milioni di persone sono state coinvolte in questa tendenza globale che sta assumendo un ritmo straordinariamente accelerato8. Da Giacarta a Parigi, dalla Germania agli Stati Uniti, questi processi scaturiscono da un movimento vitale che rivendica la gestione pubblica e partecipativa dei servizi idrici poiché offrono opportunità di sviluppo sociale, ambientale e salvaguardano le generazioni presenti e future. Emergono decine di esperienze sparse su tutto il pianeta che raccontano di buone pratiche per il ritorno dell’acqua a una gestione in cui le comunità locali possano essere di nuovo protagoniste. Risulta sempre più evidente come l’acqua sia una risorsa cruciale per costruire alleanze che abbiano il potenziale di far saltare le dighe affinché l’acqua pubblica democratica e sostenibile diventi un’ondata inarrestabile.
Colin Ward sarebbe certamente felice di sapere che anche in Gran Bretagna, patria e culla delle privatizzazioni, si è avviato un dibattito sulla necessità di fare una marcia indietro a partire dai servizi idrici.
Per quanto concerne le soluzioni alternative la visione di Ward ha certamente contribuito all’avvio di una riflessione in merito al concetto di bene comune e alle modalità di gestione. A riguardo individua nella gestione comunitaria la forma più efficace e in grado da una parte di garantire l’universalità dell’accesso e dall’altra di contrastare l’espansione del mercato. La gestione partecipativa/comunitaria, sostiene Ward, richiede di andare oltre il concetto di proprietà collettiva, di considerare invece le persone usufruttuari di quel bene, di partecipare alle scelte che lo riguardano. Va evidenziato come, probabilmente, questa prospettiva peccasse di un eccessivo ottimismo rispetto all’effettivo impatto sui processi globali ed epocali come quelli della mercificazione dell’acqua e soprattutto alla sua convinzione circa l’umana capacità di mettersi a disposizione della collettività e cooperare. Rimane, comunque, l’orizzonte verso il quale muoversi e con il quale misurarsi.
Nel libro emerge anche la consapevolezza di Ward circa le strettissime connessioni che intercorrono tra comunità locale, democrazia partecipativa e beni comuni. Ward a riguardo avverte che è l’insieme dei beni comuni che definisce lo spazio vitale della comunità e senza partecipazione e cooperazione lo spazio collettivo si restringe, si impoverisce fino all’estinzione della comunità stessa.
Inoltre, a circa trent’anni dalla pubblicazione di questo testo, abbiamo avuto la conferma del fatto che i processi di privatizzazione e di finanziarizzazione dell’acqua sono emblematici rispetto all’attacco perpetrato contro la stessa democrazia. È evidente come in atto ci sia un accentramento istituzionale da una parte e una relativa riduzione della rappresentanza dall’altra, oltre a un progressivo distanziamento dei luoghi della decisionalità collettiva dalla vita concreta delle persone. L’obiettivo appare chiaro: se ciò che è in atto è un mastodontico processo di spoliazione delle comunità locali, diviene necessario rendere loro sempre più ardua qualsiasi forma di organizzazione e di protesta, trasformando in rassegnata solitudine quella che potrebbe altrimenti divenire lotta per la riappropriazione sociale.
Purtroppo, la crisi sistemica nel nostro paese e nel resto del mondo si innesta dentro un profondo degrado delle istituzioni e della democrazia e dentro una altrettanto profonda frammentazione delle relazioni sociali. In questo senso, la sempre maggiore segretezza e opacità delle scelte istituzionali evidenzia la privatizzazione, di fatto, della politica. Da una parte, lo spazio pubblico viene trasformato in merce di scambio per interessi di gruppo familistico, clan e lobby economiche; dall’altra, emerge una totale subalternità a quella che il costituzionalista Gaetano Azzariti ha chiamato teologia della governabilità, ossia l’idea per cui tutto avviene dall’alto e l’unico problema diviene, allora, come prendere il potere9. Una società basata su tale pensiero unico non può garantire protezione e cura alcuna, entrando in piena contraddizione con la salvaguardia della vita stessa e con la garanzia dei diritti fondamentali.
Nonostante ciò, si apre, almeno potenzialmente, una biforcazione che rende possibile sperimentare le pratiche suggerite da Ward con l’obiettivo di provare a mettere in discussione le fondamenta su cui si è retta la fase neoliberista inaugurata da ormai quarant’anni e a imporre una radicale inversione di rotta mettendo al centro la tutela dei beni comuni, a partire dall’acqua, in quanto elementi fondanti la società.
Note alla prefazione
1. <https://unric.org/it/agenda-2030/>.
2. unesco, Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024: l’acqua per la prosperità e la pace, 2024.
3. Cfr. Vandana Shiva, Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, Milano, 2002.
4. un, The Sustainable Development Goals Report 2024.
5. un, The Sustainable Development Goals Report 2024.
6. <https://www.acquabenecomune.org/>.
7. Report pubblicato dal Public Services International Research Unit (psiru) e dal Multinational Observatory and Transnational Institute (tni) nel novembre 2014, <http://www.tni.org/briefing/here-stay-water-remunicipalisation-emerging-global-trend>.
8. Cfr.Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina, Olivier Petitjean, L’acqua pubblica è il futuro. L’esperienza globale della rimunicipalizzazione,Miraggi Edizioni, Torino, 2015.
9. Cfr. Gaetano Azzariti, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, Laterza, Bari-Roma, 2021.








vivo in un condominio di grande città italica in cui l’acqua potabile di fornitura non è controllata che arrivi tale essendo perlopiù inquinata dall’uso di rubinetti che la mescolano con la calda centralizzata su cui non agiscono le valvole di non ritorno. . . . . . .
il controllo, apparente o no, avvenuto in presenza dell’amministratore, dopo 1 anno non è ancora stato portato, se ottenuto dalla struttura cui si era rivolto l’amministratore ed è CALATO il silenzio