A volte in modo riconosciuto, più spesso in conflitto, di certo nei contesti urbani oltre i soggetti pubblici e il mercato c’è un vasto universo di pratiche di autorganizzazione che contribuisce ogni giorno a produrre la città, cioè a creare relazioni sociali. Con Città fai da te (Donzelli), di cui pubblichiamo l’introduzione, Carlo Cellamare propone un viaggio straordinario tra quelle esperienze che, tra molte differenze ed inevitabili limiti, mostrano come percorrere “direzioni solidali, di vita collettiva, di accoglienza nella diversità, di pluralizzazione dei significati e del senso del pubblico…”

_______________
Le città sono attraversate da pratiche e processi di appropriazione e riappropriazione, da forme diffuse di autorganizzazione, da attività e iniziative autogestite, da nuovi modelli di convivenza, da movimenti urbani che cercano di mettere in atto una diversa idea di città, con esiti peraltro differenti. Si tratta di un vasto fermento che interessa, anche se in modi molto diversificati, tutte le città del mondo.
Per qualcuno sembra sollecitare l’idea di un movimento diffuso che di fatto sta cercando di trasformare le città dall’interno, più o meno intenzionalmente in direzione opposta a quella del mainstream globale che sembra essere piuttosto l’espressione di uno sviluppo neoliberista e di un capitalismo estrattivista. Si tratta, però, di processi e pratiche differenti tra loro, che si sviluppano secondo motivazioni, logiche e modalità distinte, e che sono portatori (implicitamente o esplicitamente) di ideologie e idee di città (di società, di convivenza) molto diverse. In alcuni casi anche agli antipodi, se non addirittura in conflitto. L’idea, un po’ romantica, di un radicale processo in atto di cambiamento delle città deve essere presa con una certa prudenza, così come bisogna distinguere tra esperienza ed esperienza. E non per una moda di decostruzione, ma per una maggiore comprensione dei processi, per provare a capire quali strade sia meglio battere e in che modo. L’obiettivo è di evitare che le parole, con i loro contenuti importanti, diventino uno slogan, come è avvenuto per concetti come «sviluppo sostenibile» e «partecipazione», che sono ormai utilizzati in maniera generalizzata e acritica per processi eterogenei e che spesso nulla hanno a che vedere con i significati originari profondi. Così come per «bene comune» (o «beni comuni»), altro concetto oltremodo inflazionato, che è a rischio di svalutazione, sebbene sia stato fondamentale per portare avanti la bandiera di una certa idea di società e di città.
Le pratiche di riappropriazione o di autorganizzazione, d’altronde, non costituiscono necessariamente un fatto nuovo nella storia degli insediamenti urbani, in quanto sono state sempre presenti nella città, da quando esiste, sebbene abbiano avuti caratteri molto diversi nei secoli, a seconda delle situazioni socio-economiche e istituzionali, dei contesti culturali e sociali, delle istanze politiche ecc. Questo sforzo di rilettura critica è tanto più importante oggi, nel momento in cui tale è il successo dei processi di autorganizzazione che addirittura sono oggetto di attenzione speciale da parte dei politologi e anche delle amministrazioni pubbliche (e persino dell’Unione europea), che vedono in essi forme e processi innovativi nel governo della città. Se apparentemente questo può suscitare interesse oltre che un’importante prospettiva per il futuro, d’altra parte c’è il rischio che in ciò si annidino tentativi di delega e subdelega in un’epoca di smantellamento del welfare state, di abbandono della dimensione pubblica della città e della società, di perdita di sovranità da parte delle amministrazioni pubbliche. Certo, stiamo assistendo – anche attraverso queste pratiche e questi processi – alla costruzione/produzione di un’altra forma di pubblico, ma il carattere di questa fase del capitalismo avanzato è proprio l’ambiguità, per cui processi interessanti e sicuramente innovativi vengono «messi al lavoro» (che significa anche funzionalizzati, strumentalizzati, e alla fine sfruttati) con altri scopi e per altri interessi. Discernere è quindi fondamentale in queste condizioni di ambiguità.
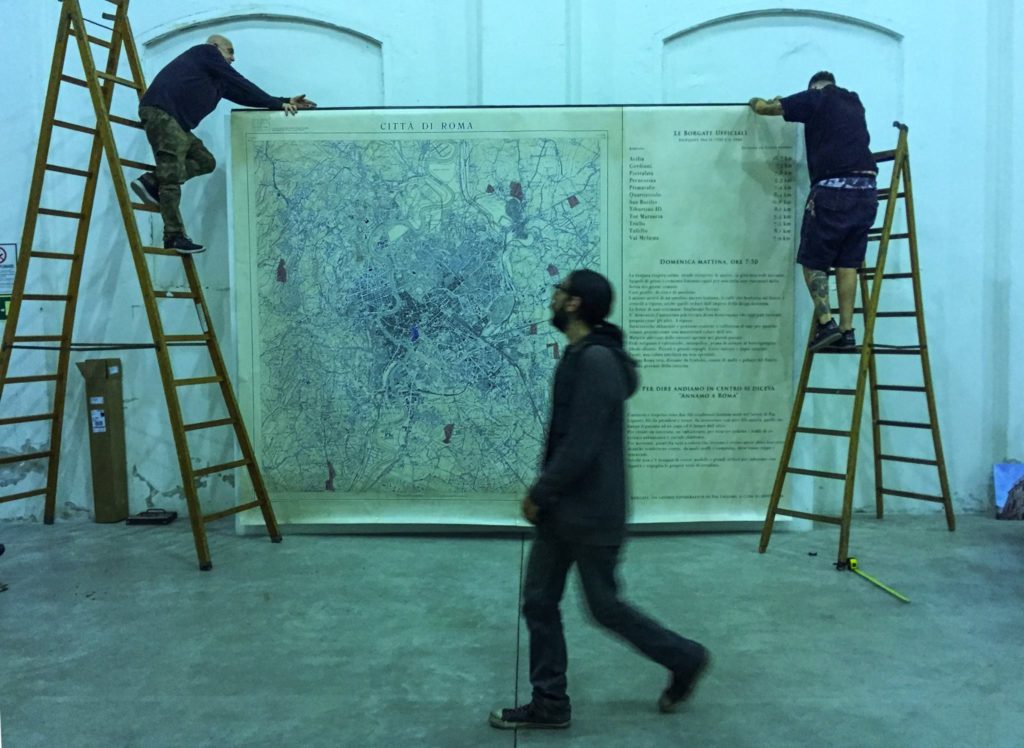
Ciò non toglie, comunque, che siamo di fronte a pratiche e processi molto interessanti, che esprimono energie sociali costruttive, che producono senso e significati condivisi. Sono il termometro di un protagonismo sociale che, sebbene ancora in fase di maturazione e con un bel po’ di problemi, sta strutturando una propria capacità di orientare la costruzione dell’urbanità (e non solo della città) in una direzione solidale, di vita collettiva, di accoglienza nella diversità, di pluralizzazione dei significati e del senso del pubblico, e infine di un’idea di città e di persona differente da quella neoliberista. E sì, perché alla fine in questi processi è in gioco un diverso modello di uomo e di convivenza che è sempre implicito, ma che è la posta in gioco più profonda. Su questi processi e su queste pratiche bisogna investire.
Infine, è anche importante riconoscere, ed è questo uno degli obiettivi fondamentali di questo libro, che esistono molti processi diversi che producono lo spazio e i luoghi, che costituiscono la città nel suo farsi. Non è solo il soggetto pubblico (lo Stato) l’artefice della città, così come abbiamo progressivamente naturalizzato con l’epoca moderna. Né tanto meno è solo il mercato, sebbene questa sia oggi la forza sicuramente più rilevante e potente nella costruzione della città. E nella sua mercificazione. Gli abitanti, e le loro forme organizzative, hanno sicuramente – nel bene e nel male – un ruolo altrettanto fondamentale nella produzione della città, che gli sia negato o gli sia riconosciuto. Ed è in questo campo conflittuale di forze che si gioca la possibilità di ripensare non solo la città, ma anche i rapporti e l’organizzazione sociale nel suo complesso, dato il ruolo crescente che le città hanno nella storia delle società attuali. La delega al «soggetto pubblico» che i «cittadini» – categorie della cultura moderna – hanno progressivamente subito o coscientemente realizzato è oggi profondamente in discussione, anzi del tutto discutibile, in una storica rottura tra «cittadini» e «istituzioni» (e «politica») che appare per molti versi insanabile, almeno nei termini tradizionali. Benché questa appaia, per le sue possibilità concrete di realizzarsi, una prospettiva molto lontana, nel ripensare i processi che producono le città oggi è in gioco il ripensamento anche dell’idea (dei concetti stessi) e dei modi di produzione del «pubblico», della «cittadinanza», delle «istituzioni».
Orientarsi in questo vasto mondo non è facile, anche perché nel calderone di una molteplicità di processi diversi che passano sotto il nome di «autorganizzazione urbana» (espressione che tende ad assumere quasi automaticamente una dimensione positiva) viene ricompreso un coacervo non strutturato di esperienze, che peraltro non sono propriamente sistematizzabili. La scelta è stata, però, di partire dalla molteplicità delle pratiche perché sono quelle che ci insegnano qualcosa. È solo entrando dentro i processi che caratterizzano ciò che Castoriadis chiama la «società istituente» che possiamo provare a trarre qualche insegnamento, qualche orientamento nel «magma dei significati sociali». È sicuramente un’ambizione; ma nell’epoca che segue la morte delle ideologie e in cui si sente diffusamente il bisogno di ricostruire una struttura di valori e significati è da lì che bisogna ripartire, applicando e sperimentando opportuni filtri interpretativi, altrimenti si ricade nel già pensato e nel già detto e si perde non solo la carica innovativa e di critica radicale, ma anche le problematiche sociali diffuse che le pratiche ci possono mostrare. In fin dei conti, questo libro è, per molti aspetti, un viaggio attraverso le esperienze.
Si tratta quindi di un approccio che non si vuole lasciare annegare nel magma indistinto delle pratiche, né vuole cedere alle sirene della sistematizzazione scientista, ma vuole cercare un orientamento, identificando e nominando valori, risorse e potenzialità. In questo modo forse potrà produrre qualche scatto nella «società istituita», riuscendo al contempo a rafforzare la capacità di maturare e di agire della «società istituente».
___________
Il libro Città dai da te sarà presentato mercoledì 11 dicembre in uno spazio autorganizzato come Scup, a Roma (via Tuscolana Vecchia 80), alle ore 18,30.
Interverranno: Chiara Franceschini, Ilaria Agostini, Enzo Scandurra, Paolo Cacciari, Riccardo Troisi, Carlo Cellamare
Modera Stefano Simoncini









Lascia un commento