La corrispondenza scolastica e la staffetta di scrittura di un diario restano due modi con cui abitare e trasformare le distanze. “Noi ci si prova, a rendere vita, a guardarci negli occhi, a costruire una prossimità che renda quella distanza sempre più corta – scrive Sonia Coluccelli, maestra – È il pensiero con cui mi sveglio ogni giorno: abitare la distanza e allo stesso accorciarla, addomesticarla, neutralizzarla. È la mia parte oggi, il mio prendermi cura di loro e di noi”
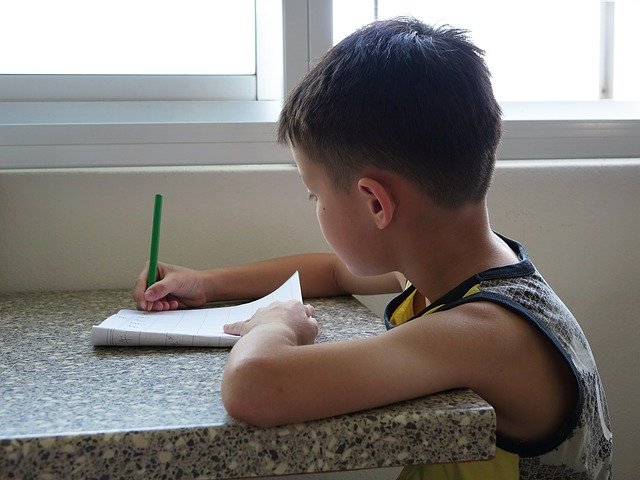
Mi mancano, i diciannove bambini della mia classe. Tantissimo. Sono un pezzo della mia casa. So che è così anche per i miei figli i cui occhi brillano e luccicano quando sullo schermo compare una maestra o l’amica prediletta e che quando la videochiamata finisce trattengono, non sempre, le lacrime.
Credo con forza che quello che più sia faticoso in questo periodo sia la sospensione della quotidianità delle relazioni, molti bambini mi dicono che resterebbero in quarantena ancora altre settimane senza problemi se solo potessero rivedere i loro amici o i nonni o le maestre. Per i bambini forse più che per noi adulti è la rete delle relazioni a fare da protezione per la salute dello spirito.
La sfida grande in questo oggi senza orizzonte è quindi quella di provare ad abitare le distanze, saperle trasformare, accogliere, rielaborare.
Pochi giorni fa ho rivolto loro una domanda molto diretta: cosa è per voi la distanza, bambini? Molti hanno parlato della nostalgia e della fatica di non poter vedere le persone che amano o praticare lo sport preferito. Altri hanno preferito fare dei distinguo importanti.
La distanza, maestra? Dipende: a volte può essere positiva se ti allontana da qualcosa che ti fa stare male o negativa se ti allontana da ciò che ami.
Altri si sono spinti a usare immagini più suggestive:
Per me è il vuoto più totale.
È l’infinito e ancora oltre.
È un muro che non si riesce a superare (e per noi che sul saltare i muri abbiamo costruito tanto del nostro lavoro in cerchio, questa è una metafora particolarmente forte e risonante).
Si fa scuola nella relazione, sì, guardandosi negli occhi che correggono la parola, potendo scambiare una carezza di conforto o di conferma, dandosi la mano, facendo spazio nel cerchio e poi appena fuori dal cancello vivendo il territorio e le risorse che contribuiscono a costruire alfabeti e responsabilità. Ma credo anche, e non vuol essere un pensiero consolatorio, che una scuola che abbia come orizzonte lo sviluppo di un senso di appartenenza alla famiglia umana la distanza che oggi sperimentiamo come limite la conosce e la abita da ben prima di adesso. Ma non solo: credo che abitare la distanza appartenga all’abitare la vita stessa in una delle sue forme.
Me lo ricorda sin dai primi giorni di questa chiusura di tutto Adenane che ha nonni, zii e cugini in Marocco e che considera le videochiamate un modo come un altro, di certo familiare, per stare insieme, chiacchierare, volersi bene. E le sue parole mi invitano a pensare a quante distanze nel nostro lavoro a scuola con queste diciannove creature ci siamo abituati a considerare parte delle relazioni ben prima delle restrizioni di queste settimane.

Da due anni abbiamo una corrispondenza con una classe di scuola primaria di Brescia, anche loro sono una scuola pubblica a indirizzo Montessori, una delle pochissime in Italia che vede una concentrazione molto alta di alunni senza nazionalità italiana. L’80 per cento della classe è di bambini e bambine senza cittadinanza italiana, quindici diverse nazionalità e storie complicate e autentiche in quell’altro cerchio che dialoga con il nostro. Quando arrivano le loro lettere è una festa e so che lo stesso capita a Brescia (a una delle forme più ricche di educazione a distanza, la corrispondenza scolastica, è dedicato questo articolo di Franco Lorenzoni: Rompere distanze).
Ci scriviamo, i bambini si chiedono e si raccontano della loro vita dentro e fuori la scuola, degli sport e dei piatti preferiti, delle materie predilette e dei progetti che li appassionano. Ogni tanto un video per saluti o auguri.
Lo scorso anno ci siamo mossi dalle rive del lago d’Orta per raggiungerli, ci hanno accompagnato a vedere il castello della loro città e una delle piazze principali, noi abbiamo portato un plastico e immagini della nostra cittadina.
E poi abbiamo ripreso a scriverci, a inviarci disegni e idee. A distanza.
Pochi mesi fa, a gennaio, abbiamo pensato di avviare un’adozione a distanza, sostenendo un’organizzazione che garantisce a bambini che hanno perso la famiglia d’origine di avere un luogo per crescere in modo dignitoso e affettivamente positivo, dopo poche settimane è arrivata la foto, accompagnata da qualche informazione, di Abu Tarek. È il nostro ventesimo compagno dicono i bambini a scuola, anche se è distante.
Abu Tarek vive in Bangladesh, un paese di cui sappiamo pochissimo, lontano. Dovremmo scrivergli, maestra, così iniziamo a conoscerci. Tutto programmato, dopo Carnevale raccoglieremo il maggior numero di informazioni possibile e poi gli scriveremo, manderemo nostre foto e attenderemo le sue risposte. Sarà tutto lento perché siamo lontani ma non importa, aspetteremo.
Siamo ognuno nelle nostre case, ora. Dopo carnevale non ci siamo più rivisti, siamo distanti anche noi. Io mi aggrappo alle parole, come sempre, a quelle che posso offrire e alla risorsa che so possono essere per ciascuno. Ognuno a suo modo. Un diario che lasci traccia dei pensieri di questo tempo, che ci permetta di essere consapevoli tasselli di una storia più grande, una scrittura a staffetta capace di restituire il pensiero collettivo che ha sempre sostenuto il nostro lavoro, un giornalino con articoli scritti a coppie.
E poi l’idea! A Brescia, nella classe con cui ci scriviamo da due anni, ci sono due bambini originari del Bangladesh, perché non li intervistiamo via skype? Prepariamo le domande che ci sembrano più interessanti e poi con un collegamento un po’ avventuroso perché siamo in tanti e dobbiamo accendere e spegnere microfoni e videocamere perché skype funzioni, ci troviamo lì, tutti i diciannove bambini e bambine di Omegna e Rafa e Ahnaf dalle loro case di Brescia dove si parla bengalese. Un’ora e mezza di domande su clima, cibi, feste e fiumi, giochi e religione, poveri, sport…. Dalle case di Rafa e Anhaf qualche suggerimento sulle domande più difficili arriva dai grandi ma i due bambini sono preparatissimi e orgogliosi.
I loro occhi lo dicono, anche se la qualità dell’immagine sullo schermo non è ottimale. Alla fine un bambino dice: è stato bellissimo, anche se eravamo distanti abbiamo potuto raccontarci tantissime cose! E comunque anche se fossimo stati a scuola avremmo dovuto usare gli stessi mezzi, i nostri amici di Brescia sono lontani.
Tra pochi giorni verrà a trovarci Lisa, che è dottoressa vicino a Padova, in un ospedale dove si concentrano i casi di Covid-19 di quella zona; nelle sue poche ore libere si siederà con noi, distante ma vicina per raccontarci com’è questa epidemia vista dal pronto soccorso dove lei lavora, per rispondere alle domande dei bambini, per aiutarci a capire, mentre siamo nelle nostre case distanti da quel mondo, case che ci sembrano un po’ prigioni che ci isolano da tutto ma che sono tali perché quello che Lisa ci racconterà è reale, in qualche modo vicino, dentro la nostra vita.
Noi ci si prova, a rendere vita, a guardarci negli occhi, a costruire una prossimità che renda quella distanza sempre più corta. È il pensiero con cui mi sveglio ogni giorno: abitare la distanza e allo stesso accorciarla, addomesticarla, neutralizzarla. È la mia parte oggi, il mio prendermi cura di loro e di noi.
*Sonia Coluccelli è un’insegnante di scuola primaria, coordina la Rete scuole Montessori dell’alto Piemonte, è Responsabile formazione della Fondazione Montessori Italia e fa parte della Rete di Cooperazione Educativa. È autrice di Un’altra scuola è possibile? (Ed. LeoneVerde), Il metodo Montessori oggi e Montessori incontra…. (Ed. Erickson). Ha aderito alla campagna di Comune “Ricominciamo da tre“.








Lascia un commento