Per affrontare il caos, è necessario trovare nuovi modi di protezione della vita, del pensiero, dell’amore. Tuttavia la consapevolezza sui rischi che corriamo, inclusa la versione apocalittica più estrema, non può essere, come pensano molti, l’assunto da cui muovere. Chi pensa all’apocalisse in realtà non pensa affatto, perché pensa a una globalità che esiste al di fuori delle situazioni concrete. Si tratta invece di accogliere la fragilità esistenziale di ogni situazione. Conferire centralità all’apocalisse significa lasciarsi intrappolare in un’idea che riduce la potenza di agire e di resistere, contribuendo a evitare le situazioni concrete nelle quali la distruzione si esprime non domani, ma qui e ora. Un capitolo di L’epoca dell’intranquillità. Lettera alle nuove generazioni (Vita e pensiero) di Miguel Benasayag e Teodoro Cohen

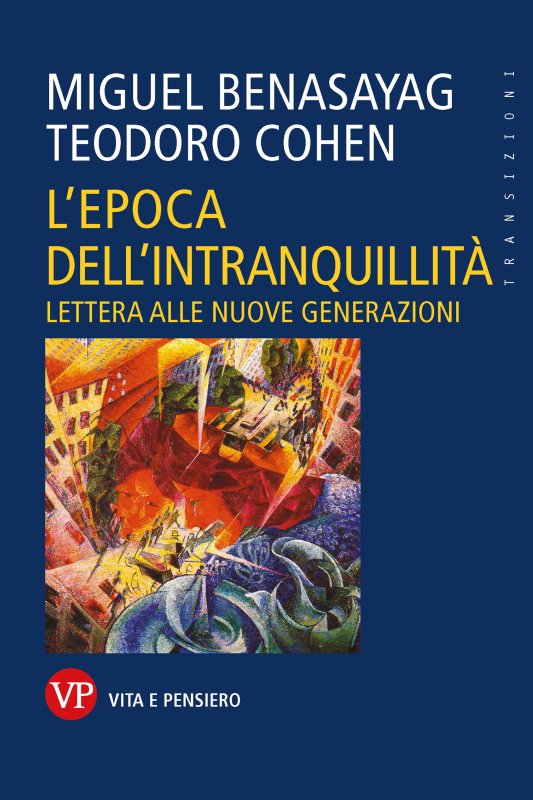
L’emergere del caos dovuto all’incontro con la complessità non rappresenta di per sé un orrore o una condanna definitiva, ma una sfida che può aprire nuove possibilità di agire, pensare, creare, vivere. Per evitare la dispersione tipica del caos, è necessario trovare nuovi modi di protezione della vita, della cultura, del pensiero, dell’amore.
In questa lettera cercheremo di proporre le nostre ipotesi a quei giovani che, come noi, “sentono” il mondo, lo patiscono e ne sono feriti. Il patire è una forma dell’impotenza che caratterizza la nostra epoca, che riguarda sia i giovani sia gli adulti. Essa è parte integrante del cambiamento di paradigma che stiamo descrivendo. Se nel paradigma della Modernità a ogni problema corrispondeva una soluzione (da trovare con l’uso della ragione), se il futuro era una promessa che illuminava il cammino teleologico di un progresso certo, anche i momenti più difficili e oscuri non erano dominati dal caos, ma da un ordine che, prima o poi, si sarebbe realizzato. Oggi la situazione è completamente diversa.
Di fronte alla distruzione dilagante non abbiamo certezze rispetto al futuro. Ai bambini che crescono con la consapevolezza della sparizione di gran parte delle specie animali e con l’angoscia che ne deriva, non possiamo rispondere tranquillamente che tutto si risolverà, che abbiamo la soluzione in tasca e sappiamo come agire. La reazione non può consistere nel girarsi dall’altra parte e distrarsi o nel negare la portata e l’impatto del caos, ma nell’integrare organicamente l’elemento caotico in un insieme. Il caos diventa così un elemento fondamentale della realtà, che viene a far parte di un’appercezione comune condivisa, non solo dagli esseri umani, ma anche dalle altre specie. Il vivente nel suo insieme è “al corrente”, secondo diverse modalità percettive, della distruzione e dell’attacco alla vita in corso. Basti pensare agli animali che subiscono lo scioglimento dei ghiacciai, le temperature troppo elevate, l’impossibilità di trovare il cibo necessario, la riduzione dei loro ecosistemi, l’inquinamento sonoro o luminoso che li disorienta, l’inquinamento degli oceani che li uccide ecc. Tutto il vivente è al corrente del disastro (“essere al corrente” non significa “essere coscienti”, come abbiamo già spiegato nel caso del disagio giovanile e della sua espressione corporea), ma dal punto di vista del patire. Per operare il passaggio necessario verso un agire che sia all’altezza della situazione, bisogna evitare di fare della consapevolezza di una possibile estinzione, così come di ogni “apocalisse”, l’assunto da cui muovere. Pensare all’apocalisse è il modo migliore di arrendersi e di evitare l’assunzione delle situazioni concrete che abitiamo e nelle quali agiamo. Chi pensa all’apocalisse, alla “fine di tutto”, in realtà non pensa affatto, perché pensa a una globalità che esiste al di fuori delle situazioni concrete e che, quindi, non esiste. Difatti, non esiste nessuna esteriorità delle situazioni, nessun mondo-contenitore che le include tutte: il mondo, il tutto, esiste solo all’interno della situazione. La minaccia, quindi, riguarda solo la situazione concreta.

Per questo e per altri motivi rifiutiamo la concezione proposta da Heidegger che definisce il Dasein (semplificando, l’umano) come l’«essere-per-la-morte», unico ente consapevole di morire e angosciato da ciò. La morte è, in questa concezione, l’elemento che sistematizza ogni situazione. In realtà, sappiamo bene che la “paura della morte” è in realtà paura e rifiuto della vita stessa, è il modo di nominare un’insoddisfazione o una sofferenza causata da ciò che si sta vivendo. L’angoscia non è mai angoscia della morte ma angoscia della vita, della fragilità esistenziale di ogni situazione. Questa falsa paura permette di evitare le situazioni concrete che ci si presentano: concentrandosi sulla morte, un falso assoluto, si voltano le spalle alle situazioni che compongono la vita e che richiedono coraggio per essere assunte. Se la mia angoscia è totalmente catturata dall’elemento centrale e assoluto, cioè la morte, le situazioni esistenziali concrete diventano secondarie e non vengono assunte.
Detto en passant, non ci stupisce affatto che il teorico dell’essere-per-la-morte abbia voltato le spalle alle situazioni tragiche della sua epoca, diventando complice di uno dei peggiori crimini che la storia umana abbia mai conosciuto. Il rifugio nell’angoscia di una morte astratta ha accompagnato il rifiuto dell’orrore per la morte concreta cui andavano incontro milioni di persone. Inoltre, nel pensiero heideggeriano, solo l’umano è in relazione con la morte. Ecco perché a questa concezione antropocentrica dell’essere-per-la morte opponiamo un essere-per-la-fragilità proprio di tutto il vivente, non solo degli umani. La fragilità è la condizione ontologica dell’esistenza, un altro dei nomi del divenire, che include la possibile morte come un aspetto, ma non come il punto centrale. Ogni vivente ha vissuto delle fragilità che lo caratterizzano e che sperimenta nel proprio corpo. È indubbio che in quest’epoca la fragilità includa anche il pericolo (e in parte la realtà) dell’estinzione possibile della nostra specie, come delle altre, così com’è indubbio che la distruzione dilagante degli ambienti e della vita è percepita, in modi diversi, da tutti i viventi. Ma questo non può mai essere l’aspetto caratterizzante delle situazioni da assumere.
La morte, o l’estinzione in questo caso, esiste sempre e solo come un “accidente”, come una variabile che può realizzarsi ma che non occupa il centro della situazione. Quando, ad esempio, si fa parte di un movimento di guerriglia, succede spesso di dover compiere azioni pericolose, come attaccare un commissariato. La domanda che può sorgere spontanea è: «Perché rischiare la vita per attaccare un commissariato?». Ebbene, in realtà ciò che ordina la situazione in quel caso è il desiderio di attaccare il commissariato per portare avanti la resistenza, non l’eventualità della morte che può avvenire come un accidente (come un incidente di percorso) e di cui sicuramente ci si assume il rischio. È sempre il desiderio (in questo caso di resistere e di compiere quell’atto) a essere primario e a organizzare la situazione. La morte è un elemento secondario e pensarci costantemente, o renderla un centro situazionale, conduce a una paralisi che non permette di assumere con il coraggio necessario le situazioni dell’esistenza. Allo stesso modo, quindi, conferire centralità all’apocalisse e all’estinzione finale significa lasciarsi intrappolare in un’idea inadeguata che diminuisce la nostra potenza di agire e di resistere, contribuendo a evitare le situazioni concrete in cui la distruzione si esprime non domani, ma qui e ora.
Titolo completo del capitolo Dalla paura della morte all’assunzione della fragilità









Bellissimo e vero. Grazie mille volte.
Incoraggiate a non mollare a restare in piedi di fronte allo sfascio dilagante.
Hai ragione Stefano, un punto di vista incoraggiante.