L’accoglienza diffusa è nata per cambiare la società prima ancora di «fare accoglienza». Nei momenti di disordine e incertezza ha molto da offrire

Erano gli anni Novanta. Nemmeno trent’anni fa. E la guerra l’avevamo in casa (per citare un libro, a noi molto caro, di Luca Rastello). Non si può parlare di accoglienza diffusa e di diritto d’asilo in Italia senza tornare a quel periodo. Certo, prima c’era stato il 1990, con l’omicidio di Jerry Masslo, i funerali di stato, la legge Martelli che portava per la prima volta l’asilo nella legislazione italiana. Ma è solo qualche anno dopo, quando nei Balcani così vicini a noi bruciavano le città e le vite di tante, troppe famiglie, che entriamo a piè pari in una stagione nuova. Si stima che almeno 20.000 cittadini italiani abbiano preso parte a interventi oltre confine, prevalentemente orientati all’assistenza umanitaria verso i profughi dislocati in Slovenia e Croazia. Normali cittadini, pacifisti, che sono tornati con testimonianze dirette, subito diffuse col passaparola a livello locale.
Gli stessi protagonisti si sono spontaneamente attivati per accogliere (ma spesso anche per far arrivare) rifugiati e disertori in fuga dai diversi paesi della ex Jugoslavia: un impegno consistente, con Comitati locali molto attivi (tanti dei quali confluiti nel Consorzio Italiano di Solidarietà), che hanno trovato naturale rivolgersi – come primi interlocutori – agli enti locali, mentre il governo centrale non riusciva a organizzare una risposta efficace e tempestiva.
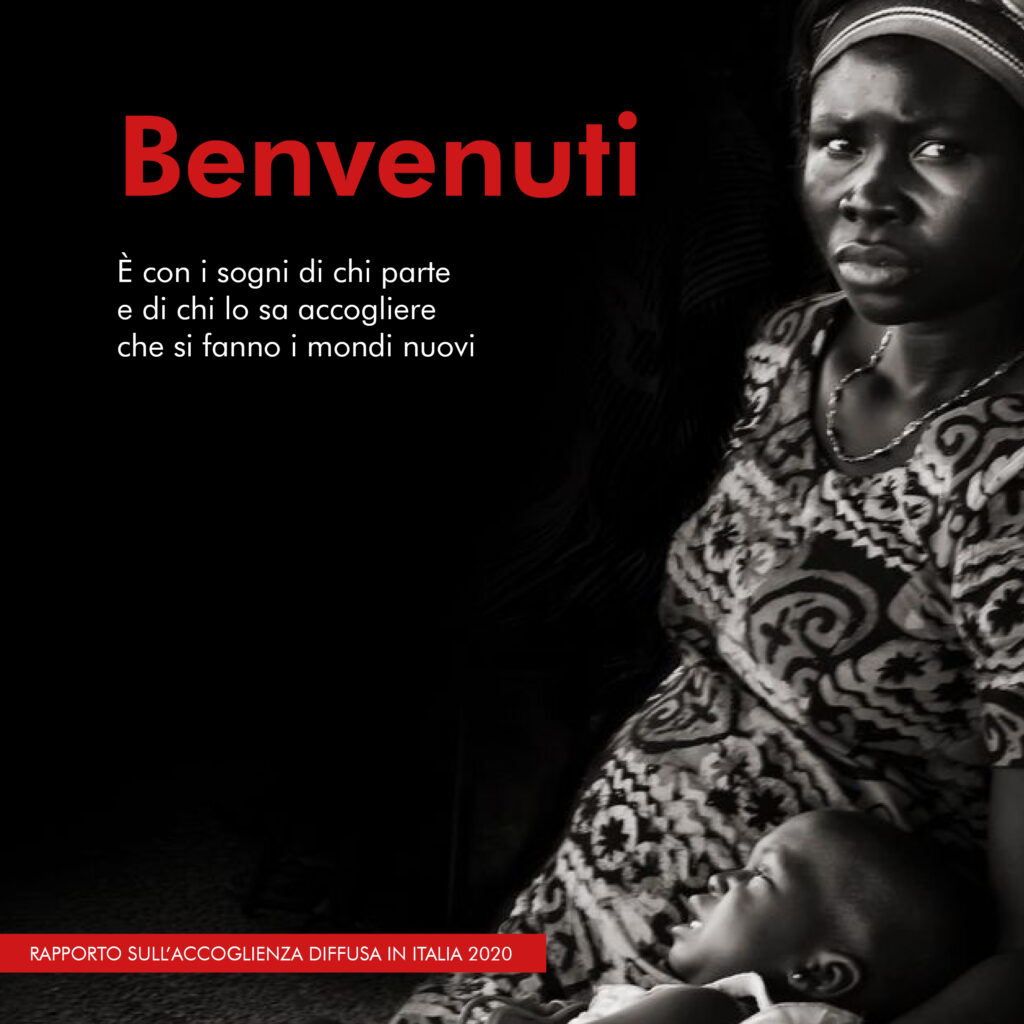
A Parma, Ciac (il Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale) nasce proprio da quello stesso humus. Nel 1993 viene lanciata la campagna «Fermiamo un fucile per volta» per l’accoglienza e il sostegno dei disertori della guerra nella ex Jugoslavia. L’impegno contro la guerra e a fianco della popolazione civile prende la forma di azioni di “diplomazia dal basso”. Dal Comune di Parma nel 1993 avevamo avuto un appartamento per realizzare l’accoglienza, che autofinanziavamo. Ospitammo obiettori (disertori) provenienti da ogni regione della ex Jugoslavia, di ogni etnia, di ogni religione e tra di loro la convivenza pacifica si realizzava sempre, come a dimostrazione di un teorema.
Già dagli anni Novanta prendevano corpo alcune evidenze, che ci fanno da stimolo e da guida ancora oggi. L’assenza in Italia di una legge organica sull’asilo spiegava la mancanza di strutture statali per l’accoglienza. Solo duemila profughi dei circa ottantamila «sfollati di guerra» giunti nel periodo compreso tra il 1991 e il 1995 vennero accolti nei centri istituzionali. Inoltre, non era sufficiente – da solo – l’impegno del volontariato, occorreva far pressione affinché lo stato assolvesse al proprio dovere di ospitalità e protezione. E le associazioni potevano innanzitutto riuscire a coinvolgere le istituzioni più raggiungibili: i comuni, le province.
Perché raccontare queste origini? Perché in Italia, se non ci fossero state esperienze come questa (quella del Ciac non è certamente stata la sola), portate avanti con tenacia e anche un pizzico di azzardo da gruppi informali, associazioni, comitati di cittadini, molto probabilmente un sistema nazionale di accoglienza diffusa non avrebbe mai visto la luce, per lo meno non con le caratteristiche che poi hanno preso i diversi programmi nazionali: Azione Comune, Piano Nazionale Asilo e poi dal 2003 il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar) che, fino al suo snaturamento a causa del famigerato Decreto Immigrazione e Sicurezza nel 2018, ha rappresentato un’esperienza concreta – se pur mai del tutto compiuta – di come avrebbe potuto essere un sistema nazionale davvero tutelante sia per i rifugiati che per le comunità che li accoglievano.
Queste radici vanno richiamate perché raccontano di un’articolazione dei rapporti tra società civile e istituzioni, tra spinta dal basso e necessità di raggiungere e modificare le istituzioni e le leggi, che realizza forme di sussidiarietà di cui oggi più che mai si avverte l’urgenza. Senza nemmeno saperlo, le prime esperienze degli anni Novanta stavano sperimentando pratiche di quella che oggi viene definita “innovazione sociale”: ovvero esperienze in cui non solo si soddisfano bisogni che precedentemente non erano affrontati o comunque non trovavano una soluzione, non solo si innescano processi di trasformazione delle relazioni sociali nella direzione di una diminuzione dell’esclusione sociale e si attiva una comunità nel tentativo di alleviare i problemi sociali identificati; ma soprattutto – e questo non va dimenticato in un momento storico in cui anche gli attori dell’accoglienza sembrano troppo spesso schiacciati in un ruolo di meri gestori – in cui si realizza una governance innovativa, ossia una modalità di relazione tra attori pubblici e privati tale per cui il terzo settore è legittimato a partecipare attivamente al processo di policy making, mentre allo stesso tempo l’attore pubblico è chiamato a salvaguardare i diritti universali.
È quest’ultimo aspetto che qualifica l’atteggiamento di chi non pensa solo ad aumentare i posti e i servizi di accoglienza o di aumentare i finanziamenti pro die pro capite, ma piuttosto si concentra sul contributo che ciascuno – dalla sua posizione e dal suo ruolo – può dare per rendere finalmente esigibili i diritti di ciascun richiedente asilo, rifugiato, migrante: e certamente questa non è una garanzia che può essere data dal volontariato o dalle associazioni da sole. Questi ultimi soggetti tuttavia hanno una missione imprescindibile che consiste nell’aprire piste e cammini (negli anni Novanta, come negli anni Venti del Duemila), nel fare pressione mostrando alle istituzioni cosa già si sta facendo e quanto di più si potrebbe fare con un’adeguata assunzione di responsabilità da parte dei diversi livelli di governance locale, regionale e nazionale.
E gli ingredienti per (ri)costruire un sistema nazionale incentrato sull’accoglienza diffusa sono gli stessi di sempre, con qualche accortezza in più che discende dalle esperienze di questi anni.
Primo: i diritti sono universali ma i contesti sono locali. Non si può garantire equità e piena esigibilità dei diritti se il sistema è frammentato, oggetto di contesa politica e di ricerca di consenso, basato sulla “buona volontà” di chi lo anima. Per questo è cruciale un’articolazione responsabile e chiara tra livelli nazionali, regionali e locali. E nessuno si può sottrarre dall’offrire – attraverso un sistema pubblico, riconoscibile, capillare – presidi e servizi qualificati, in un rapporto dinamico con il territorio e i bisogni (manifesti o latenti) portati da richiedenti asilo e rifugiati, a prescindere dalla fase del loro percorso. Non si può essere quindi sistema nazionale finché tutte le istituzioni locali non saranno tenute a rispondere sulle risposte che sanno dare all’obbligo – non all’arbitraria disponibilità – di partecipare alla garanzia di un pieno diritto di asilo.
Secondo: un sistema di accoglienza diffusa non può essere chiuso in se stesso. Avere in mente innanzitutto i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati non significa mettere in piedi un sistema chiuso, autoreferenziale, iperspecializzato. L’accoglienza diffusa non può diventare l’alibi per costruire un sistema di servizi in apartheid per categorie variamente intese come “svantaggiate” o scomode. In questo senso il dialogo e la co-progettazione con un terzo settore portatore di competenze specifiche ma anche di visioni più ampie e coraggiose sui diritti, la cittadinanza, la solidarietà deve fare da sprone continuo per non rinchiudere in una mera erogazione di prestazioni a beneficiari che possono accedervi solo in quanto portatori di bisogni e vulnerabilità ben codificati e continuamente ridefiniti. In questo senso l’accoglienza è pienamente “diffusa” se si proietta fuori dalle proprie anguste mura: in termini spaziali (fuori dalle proprie case, dai propri uffici) ma anche di destinatari (costruire opportunità accessibili anche ad altri, stabilire connessioni e non separazioni, secondo un approccio whole-of-the-community). Se pensa a cambiare la società prima ancora che a “fare accoglienza”.
Terzo: la protezione non è (solo) un pezzo di carta. Ampliare e aggiornare le categorie e i requisiti per riconoscere a chi chiede asilo in Italia una qualche forma di protezione è un prerequisito di qualsiasi sistema di accoglienza che non sia già alla base escludente e poco tutelante. Se nel futuro di più dell’80 per cento dei richiedenti asilo c’è la prospettiva di un diniego e della caduta nell’irregolarità, non c’è qualità dell’accoglienza che possa compensare le ricadute negative per le persone coinvolte ma anche per i territori nel loro complesso. Allo stesso tempo, questa consapevolezza – che deve costituire anche le fondamenta delle rivendicazioni comuni degli attori del sistema di accoglienza – non può rappresentare un alibi per non considerare l’importanza della protezione che si costruisce altrimenti e altrove: l’orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio, la cultura della legalità per imparare a difendersi dai soprusi e dallo sfruttamento (anche se si è in condizioni di irregolarità), la centralità di una rete protettiva offerta da relazioni sociali ampie, solidali e interculturali, a cui si può accedere anche e soprattutto attraverso la facilitazione dell’accoglienza diffusa.
Quarto: le storie sono sempre più grandi di noi (e dell’accoglienza). A differenza di altre forme di accoglienza che prediligono soluzioni standardizzate, con la priorità esplicita del controllo e della disciplina, o – nel migliore dei casi – di un’assistenza non negoziabile, l’accoglienza diffusa mette al centro la soggettività dei veri protagonisti: i richiedenti asilo e i rifugiati. L’analisi critica dei processi di passivizzazione e disattivazione degli accolti deve rappresentare l’oggetto quotidiano di riflessione e riorganizzazione degli operatori e delle organizzazioni pubbliche e del privato sociale che promuovono l’accoglienza. Le trappole della relazione di aiuto, il rischio del binomio onnipotenza-frustrazione che genera così diffusamente casi di burn out in chi lavora in prima linea devono essere oggetti concreti di ripensamento delle pratiche, che vanno continuamente poste al vaglio degli attori principali: i rifugiati. Rimettere al centro le aspirazioni, le traiettorie, le complessità e talvolta la contraddittorietà delle vicende biografiche di ciascuno comporta riconoscere sempre la parzialità del proprio ruolo e la grandezza delle storie che incrociamo. Persone che fanno un tratto di strada con noi, ma che non siamo tenuti a conoscere del tutto e controllare, nemmeno a fin di bene. Solo con questo spirito l’accoglienza diffusa può diventare una vera palestra di “cittadinanza anticipata”, grazie alla quale – al di là delle risposte che sapremo e potremo dare – le persone si sentiranno viste e riconosciute come soggetti pieni: di diritto e di vita.
Per concludere, coerentemente con quanto appena esposto, credo che la definizione e la costruzione di un sistema di accoglienza diffusa ci riguardi tutti, a partire da chi come Ciac – ma con noi tanti altri dal Nord al Sud dell’Italia – ha cercato durante tutta la sua esistenza di resistere alle tempeste, senza ripiegare su se stessi. Perché non si fa accoglienza diffusa solo quando e se si ha di fronte a sé un sistema perfetto e compiuto. La si fa nella quotidiana capacità di rileggere le sfide del presente, i limiti posti dai continui mutamenti normativi, sociali (e non scordiamoci quelli di salute pubblica che abbiamo tristemente imparato a vivere in tempi di pandemia), mantenendo una direzione e una tensione verso una rotta che ha alcuni punti cardinali fermi ma che non è mai statica e data una volta per tutte. Per questo mi sembra di grande ispirazione l’invito di Nassim Nicholas Taleb a imparare a «prosperare nel disordine»: e i soggetti più adatti a compiere quest’impresa non sarebbero i più «resilienti» o i più «robusti» ma gli «antifragili», ovvero coloro che riescono di fronte agli shock e alle prove della vita a non rimane identici a se stessi, ma addirittura a migliorare. In questo, i migranti e i rifugiati hanno tanto da insegnare agli attori dell’accoglienza.
Chiara Marchetti, docente di Sociologia delle relazioni interculturali presso l’Università degli Studi di Milano e di Sociologia della globalizzazione presso l’Università degli Studi di Parma, lavora nell’ambito della progettazione e della ricerca sui temi dell’asilo con l’Associazione CIAC Onlus di Parma.











una riflessione potente, brava chiara. a cui aggiungerei solo il dilemma della precarizzazione degli operatori che si occupano di accoglienza, il che spesso disperde competenze, energie, opportunità.
L’accoglienza presuppone una partecipazione attiva alla vita dei migranti e, senza dubbio le necessarie solidità che, il nostro malandato paese ancora non possiede .